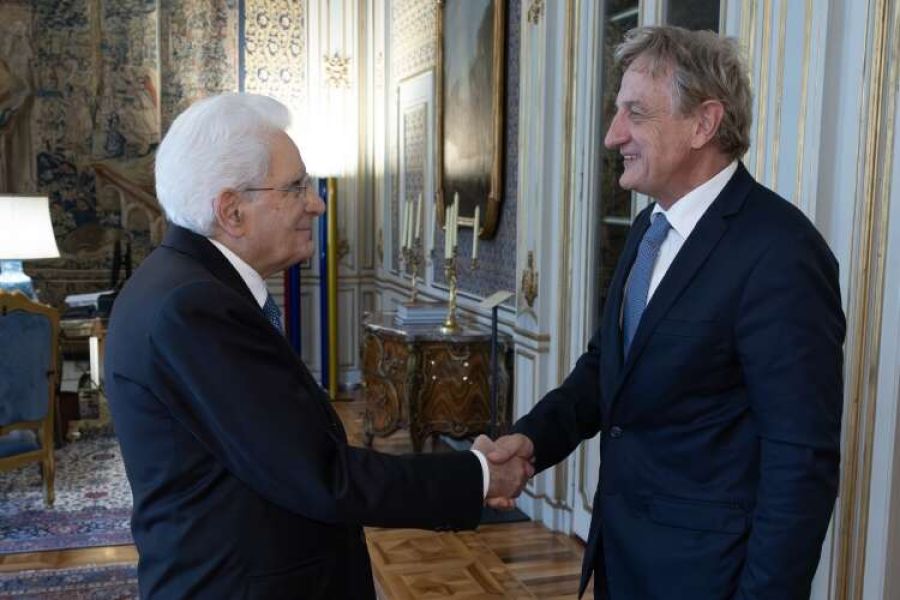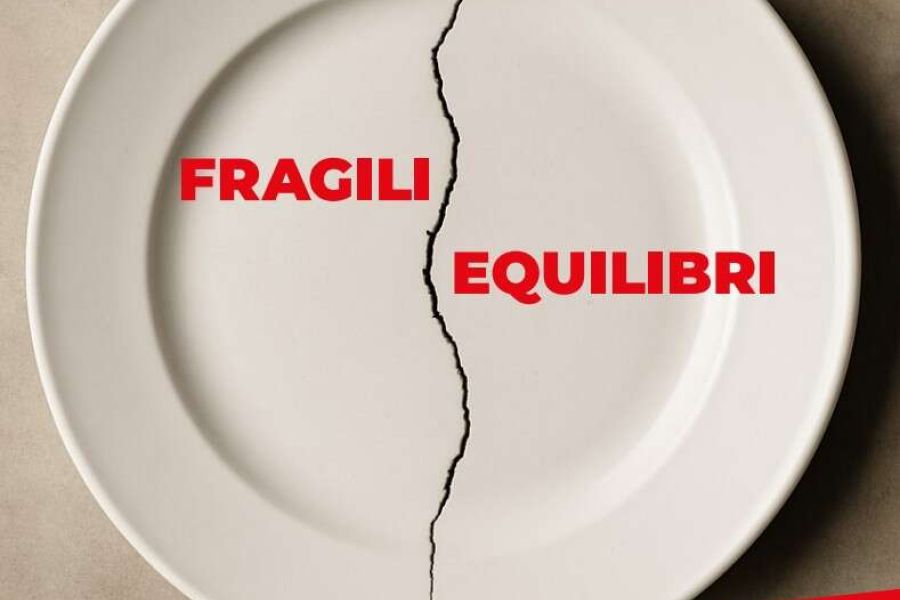Manifesto per una società della cura, oltre quella dei diritti à la carte

La pandemia ha squarciato il velo e mostrato in modo definitivo una tara di sistema della nostra società e delle istituzioni che la governano: l’incapacità di mettere al centro la cura intesa non solo in senso sanitario, ma come sistema integrato di politiche imperniate sui diritti individuali, collettivi, ambientali. E’ per questo che nasce la Società della Cura: un percorso di convergenza di centinaia tra organizzazioni sociali, movimenti e gruppi locali che ha come obiettivo un cambiamento radicale a livello economico e sociale. Primo appuntamento di mobilitazione: 21 novembre.
Nella prima fase della pandemia, l'indebolimento di lunga data dei sistemi sanitari, in alcune Regioni più che in altre, ha mostrato sulle reti nazionali lo spettro di dover decidere per chi ricorrere alla ospedalizzazione o usare le terapie Intensive. Le differenze territoriali in questi giorni ci sono ancora più palesi, con le varie Regioni che decideranno restrizioni non solo alla mobilità, ma anche all'esercizio del diritto scolastico o al lavoro.
Per i lavoratori e le lavoratrici, in mancanza di integrazione di reddito, si tratta di decidere tra diritto al lavoro e diritto alla salute, considerando che la disoccupazione ha colpito soprattutto donne prive di una occupazione stabile e giovani tra i 18 e i 34 anni, spesso con lavori precari e contratti a termine (-2,2%, rispetto al -1,2 globale, secondo dati ISTAT relativi al secondo trimestre 2020).
La conseguenza è l’aggravamento della condizione di chi finora riusciva a stare in equilibrio funambolico sulla soglia di povertà (oltre 450.000 nuovi poveri 'assoluti' solo tra marzo e maggio 2020, dati Caritas, in crescita) che con la crisi ha visto crollare ogni certezza. Tutto questo legittima parlare di 'pandemia sociale', e ha portato a confondere i confini e i ruoli tra Stato e società civile visto che, troppo spesso per supplire alle carenze politiche e istituzionali, si è guardato a una schiera sempre più nutrita di associazioni e gruppi informali mobilitatisi in risposta a bisogni assolutamente primari (distribuzioni alimentari, ma anche sostegni alla scolarizzazione, trasporti, ecc). E la gestione di questa crisi deve tanto alle donne che si sono tornate ad essere relegate automaticamente a prime se non uniche responsabili del lavoro di cura, patendo 'gli effetti negativi della pandemia – dalla salute all'economia, dalla sicurezza alla protezione sociale – semplicemente in virtù del loro genere' come dichiarato dalle stesse Nazioni Unite.
Nel meccanismo di sussidiarietà schizofrenica, se non addirittura invertita, cui si è assistito in molti territori, si sono persi ancora più di vista gli imperativi di risposte istituzionali dettate dai diritti, e la stessa società civile organizzata ha avuto fasi di smarrimento fisiologiche, pur continuando a tessere a livello locale tori economie sostenibili, la difesa dei beni comuni e dei diritti collettivi, nell’ottica di cambiare rotta. Perché le risposte alla pandemia sociale, sul lungo periodo, rischiano di essere non solo insufficienti, ma anche insostenibili. Mentre sullo sfondo rimane la necessità di contenere il debito, come sottolineato recentemente dal Commissario UE Gentiloni, l’esigenza di rilanciare il PIL rischia di dare il via a politiche di sfruttamento del territorio, di grandi opere e infrastrutture che, oggi come non mai, impattano su un Paese in forte dissesto idrogeologico
Il cambio di paradigma diventa quindi necessario, e per questo è nato un percorso collettivo che sta chiamando a raccolta la società civile e i movimenti italiani. La Società della Cura (per adesioni:
di Lara Panzani e Alberto Zoratti, per greenreport.it