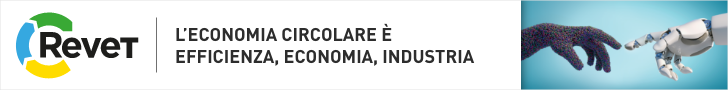Perché il potere del dollaro sul sistema economico globale si sta riducendo, e cosa può fare l’Europa per approfittarne

Ero un ragazzo e mio padre, come uno che la sapeva lunga, mi diceva sempre: il dollaro è una moneta che vale perché ha dietro “l’oro di Fort Knox”. Ecco spiegato in due parole il Gold Exchange Standard, cioè il sistema monetario internazionale in vigore dal 1944 al 1971, introdotto con gli accordi di Bretton Woods. In questo sistema, tutte le valute nazionali erano ancorate a tassi di cambio fissi rispetto al dollaro Usa, che a sua volta era convertibile in oro a un prezzo fisso. In pratica, il dollaro fungeva da valuta di riserva internazionale, sostituendo in questo ruolo la sterlina britannica, e le banche centrali detenevano riserve sia in oro che in dollari statunitensi.
Un grande strumento di stabilità per gli scambi internazionali, con una moneta sempre (e in maniera crescente) disponibile grazie agli ampi movimenti di capitali americani verso il resto del mondo. Per investimenti esteri, per aiuti internazionali e per spese militari a sostegno di basi nel resto del mondo e di guerre, fra cui resta indimenticabile per drammaticità, ma anche per esborso finanziario, quella del Vietnam.
Ma tira tira, poi la corda si spezza. E a fronte di una eccessiva invasione di dollari nel mondo, con qualche “aiutino” francese di tipo speculativo, la situazione divenne insostenibile. La certezza di mio padre collassò in un giorno. L’oro di Fort Knox non bastava, neppure minimamente, a coprire la massa di dollari nel mondo e per questo nell’assolato Ferragosto del 1971 fummo svegliati dalla dichiarazione ufficiale di Nixon sulla fine della convertibilità del dollaro in oro.
Fa l’avvio di misure e contromisure – fra cui in Europa il primo tentativo, nel 1972 – per avviare un percorso di coordinamento fra le monete denominato “serpente monetario” che poi, fra alterne vicende, condusse nel 1999 all’introduzione dell’euro.
Ma la situazione fu subito chiara a tutti: la narrazione di mio padre era finita. Non c’era più nulla di “fisico” dietro le monete, neppure dietro al dollaro, ma queste come la bandiera, i capi di stato e le istituzioni, contavano e valevano solo in funzione della “fiducia” realmente esercitata sul resto del mondo. E quindi, siccome la fiducia va e viene a seconda dei periodi e delle politiche economiche e monetarie realizzate in ogni Paese, ecco la fluttuazione come norma di comportamento del “nuovo sistema monetario”.
Tutti fluttuano, specie, per quanto riguarda l’Europa prima dell’euro, i singoli Paesi con scarso peso economico internazionale, ma alla fine il dollaro pur disarcionato dal cavallo aureo di Fort Knox continua ad essere la moneta di riferimento del mondo. Il dollaro rimane la valuta di riferimento mondiale grazie al peso economico degli Stati Uniti, al ruolo centrale nel commercio internazionale, alla solidità dei mercati finanziari Usa, alla diffusione globale di contratti e debiti denominati in dollari, e alla mancanza di alternative altrettanto liquide e affidabili.
In tutto questo sistema di “elementi fiduciari” di tipo prevalentemente economico, non può essere sottovalutato il ruolo geopolitico degli Usa nel campo militare. Per gran parte del mondo sviluppato, gli Stati Uniti hanno rappresentato il “gendarme del mondo” contro regimi autoritari, contro Paesi e movimenti che negano la libertà individuale e il mercato come fondamento economico e, pur fra tante contraddizioni interne, a favore dello sviluppo dei diritti civili a scala globale. Nel 1999 il dollaro arriva a rappresentare oltre il 70% delle riserve mondiali. Dopo il 1971 la “pompa” che permette la disponibilità di moneta nel mondo, oltre ad alcune delle consuete variabili finanziarie, comincia ad essere il sempre più forte sbilancio commerciale degli Stati Uniti, che arriva oggi a quasi 1000 miliardi di dollari.
Come più volte sostenuto dal famoso economista Robert Triffin, questa situazione appare insostenibile dal punto di vista economico per il famoso “dilemma di Triffin” in quanto gli Usa devono avere una bilancia commerciale in passivo per pompare dollari per il sistema globale, ma nello stesso tempo devono avere “conti in regola” per non perdere la fiducia. Ma appare insostenibile anche dal punto di vista etico, perché il Paese più ricco del mondo si fa sostenere col contributo del resto del mondo. Un contributo che viene pagato semplicemente attraverso “pezzi di carta”. Sicuramente credibili e commerciabili, ma sempre di carta.
Ma il mondo sta cambiando. Il primo elemento di cambiamento è che il dollaro si mantiene sempre la principale moneta di riserva, ma con un peso decrescente. Oggi intorno al 58% a fronte di un 20% dell’euro. Le altre monete stanno ancora a livelli bassi: lo yen al 6%, la sterlina al 5% e il renmimbi al 3%. Se consideriamo il peso sul commercio internazionale, l’euro e il dollaro si avvicinano in maniera sensibile: diciamo un 40/50% di dollaro a fronte di un 30/35% di euro.
Ci sono nuove monete che non afferiscono più a singoli Paesi ma di tipo “privato”, come le criptovalute e le stablecoin, che si stanno affacciando oltre che nell’area commerciale anche in quella di riserva e che, pur potendo legarsi a singole monete nazionali forti come il dollaro, sono più aperte a soluzioni innovative in grado di allontanarsi dalla tradizionale moneta forte.
Quindi c’è da parte degli Usa un forte e crescente debito pubblico, che richiede un livello di gestione dei titoli di stato sempre più complesso e che già ora – ma ancora di più nel medio periodo – può mostrare delle difficoltà in grado di inficiare la fiducia su cui si basa la forza del dollaro.
Infine, sul fronte geopolitico e militare, se è vero che gli Usa rappresentano ancora, per livello quantitativo e qualitativo di spesa e di organizzazione, il top del mondo, cionondimeno, anche su spinta dell’attuale presidente degli Usa Donald Trump, gli altri paesi del Nato sono destinati, e costretti per alcuni versi, a rafforzarsi in questo settore strategico.
Tutti questi elementi spingono verso un ridimensionamento del “potere del dollaro” sul sistema economico globale. Non è detto che questo spazio sarà, per semplice forza di gravità, riempito dalla seconda moneta in graduatoria nel sistema di riserva e in quello degli scambi commerciali. Ma si apre certamente una partita aperta dove i giocatori sono tanti, e agguerriti, e dove è davvero difficile capire quale sarà il momentaneo punto di convergenza.
E in questa partita l’Europa deve mettere a punto una serie di innovazioni ineludibili. La prima: come oramai detto in più documenti strategici, l’Europa deve creare davvero un mercato unico dei capitali, aperto, trasparente ed efficiente. Quindi l’euro deve puntare il prima possibile alla digitalizzazione per poter “dialogare” col nuovo mondo delle monete private e con le tecnologie di supporto a queste monete e anche, cosa non secondaria, per rispondere in parte alle esigenze che quelle monete riescono a soddisfare.
Infine, occorre che l’Europa, come ha sempre fatto gli Stati Uniti negli ultimi 80 anni, sfrutti la forza geopolitica e militare a sostegno della propria economia e della propria moneta. Arrivare al 5% della spesa militare senza diventare una “potenza” alla pari dei grandi colossi mondiali sarebbe davvero un’occasione persa e sarebbe, per di più, un esborso immotivato rispetto al ruolo svolto nello scacchiere internazionale. Ed invece la spesa militare europea, magari anche molto al di sotto del 5% ma integrata a livello di Unione, deve essere una spinta a creare un settore industriale e tecnologico innovativo europeo e a sviluppare, all’interno di un mondo multipolare, una visione “difensiva e non aggressiva” del proprio potenziale militare. Anche in questo modo l’Europa potrebbe giocare un ruolo tradizionale, legato al diritto internazionale e alla difesa dei principi e delle istituzioni che lo supportano, a fronte dell’affermarsi nel mondo di comportamenti aggressivi e illiberali delle vecchie e nuove autocrazie.