
Un clima dissonante. Perché il negazionismo è un fatto psicologico, prima che ideologico e politico
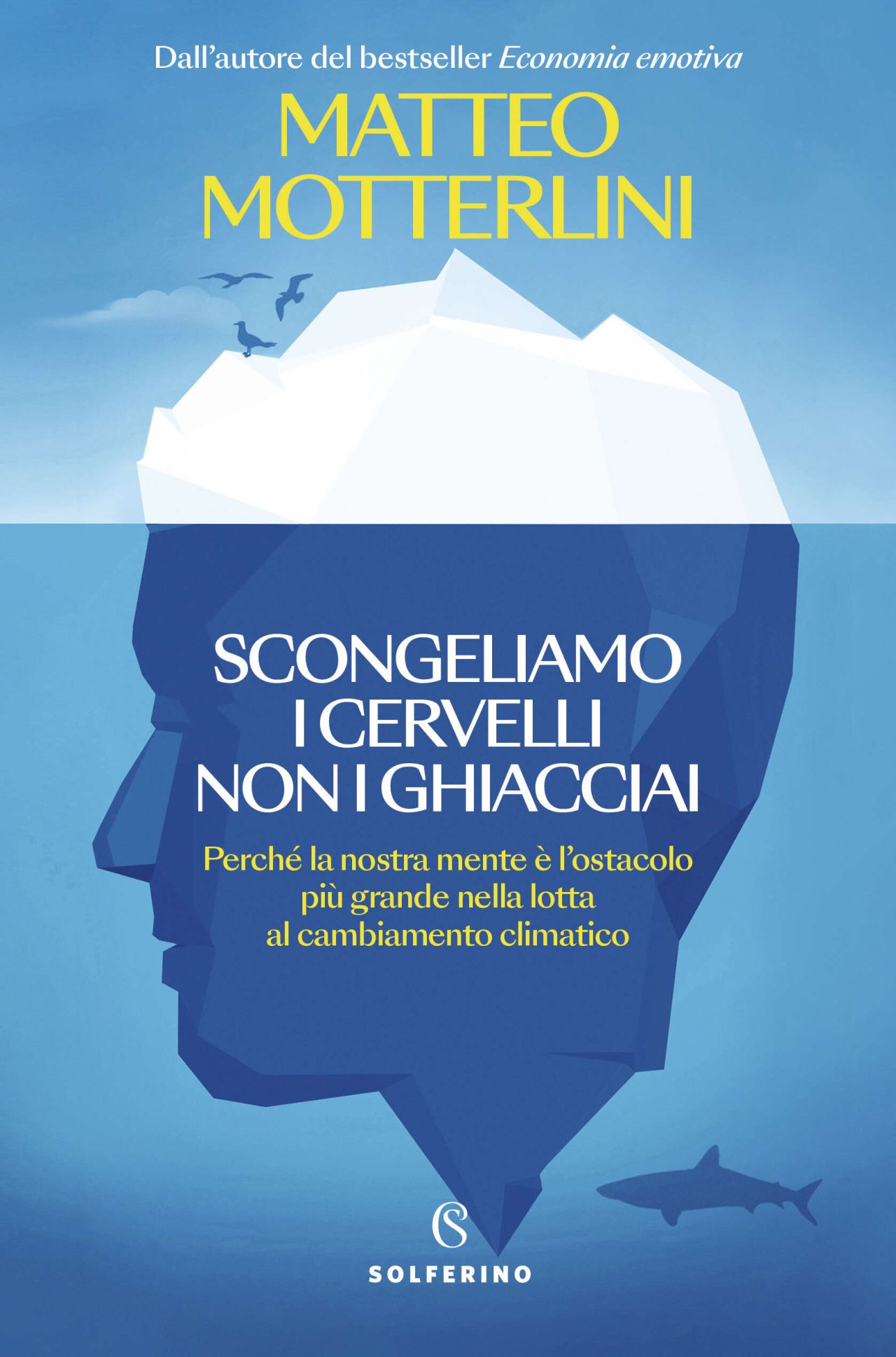
Negli anni Cinquanta, una casalinga del Michigan di nome Dorothy Martin annunciò che il mondo sarebbe finito il 21 dicembre 1954. Ma niente panico. Grazie a messaggi ricevuti da alieni del pianeta Clarion, era certa che un’astronave avrebbe salvato i veri credenti. Il gruppo si chiamava The Seekers, e alcuni membri, per prepararsi all’evento, lasciarono famiglia, lavoro e beni terreni.
A interessarsi alla vicenda fu Leon Festinger, psicologo sociale newyorkese, allora ricercatore all’Università del Minnesota. Invece di liquidare la profezia come un’assurdità, la vide come un’occasione unica per osservare cosa sarebbe successo quando, come prevedibile, la profezia non si fosse avverata.
La notte del 21 dicembre arrivò. Nessuna catastrofe. Nessun disco volante. Ma invece di disgregarsi, il gruppo rinsaldò la propria fede. Dorothy dichiarò che, grazie alla devozione dei Seekers, gli alieni avevano deciso di risparmiare la Terra. E i seguaci, di fronte al fallimento della profezia, ci credettero ancora di più.
Festinger aveva appena assistito alla dissonanza cognitiva in azione. Per ridurre la tensione psicologica provocata dal confronto tra due rappresentazioni mentali inconciliabili (da un lato la fine del mondo, dall’altro il fatto che il mondo fosse ancora lì), i membri del gruppo non abbandonarono la credenza iniziale, ma la ristrutturarono. Secondo la teoria, che Festinger avrebbe formulato proprio in quegli anni, quando viviamo un conflitto tra ciò che crediamo e ciò che accade, si attiva una motivazione interna a ridurne la distanza. Lo si può fare modificando le proprie idee, cercando nuove giustificazioni o minimizzando il conflitto. I Seekers scelsero la via della reinterpretazione: la fine del mondo era stata evitata proprio grazie alla loro fede. Il paradosso si risolveva trasformando la smentita da parte dell’evidenza in un’ulteriore prova della validità della loro credenza negli alieni. Un caso scuola di come la dissonanza cognitiva possa orientare il comportamento umano in modi tutt’altro che razionali.
L’episodio di Dorothy Martin fu al centro del libro Quando la profezia non si avvera (1956). Ma Festinger dimostrò il fenomeno anche in laboratorio. In un esperimento famoso, chiese a un gruppo di partecipanti di svolgere un compito estremamente noioso (spostare bacchette su un vassoio per un’ora) e poi di dire al partecipante successivo che l’attività era stata divertente. Alcuni ricevettero venti dollari per mentire. Altri, appena uno. I risultati non furono meno sorprendenti del caso degli alieni: chi aveva ricevuto solo un dollaro finì per convincersi che il compito non era poi così male. Perché? Perché mentire per venti dollari può avere un senso. Ma per uno solo, no! E allora il cervello si adatta piegando la realtà: magari quel compito mi è piaciuto veramente. Mentire è brutto, ma sentirsi incoerenti lo è di più.
Festinger aveva colto un meccanismo universale. Non riguarda solo le sette apocalittiche. Riguarda tutti noi. Quando pensieri e azioni non coincidono, non sempre cambiamo comportamento. Spesso cambiamo la narrazione. Per sentirci in pace con noi stessi.
Pensiamo alla salute. “Voglio mangiare sano, ma ho appena divorato un Big Mac”. Potrei ammettere l’incoerenza e correggere la rotta. Ma è faticoso. Più semplice raccontarmi che “tanto poi salto la cena”. La realtà viene leggermente limata, giusto quanto basta per calmare il fastidio psicologico. Una piccola bugia a fin di coerenza. Succede con i consumi. Compro l’ultimo smartphone da mille euro, anche se il mio funziona ancora benissimo. So che produrlo ha richiesto terre rare, litio, lavoro sottopagato e una bella dose di CO₂. Ma invece di ammettere che ho ceduto al desiderio, mi convinco che “mi serve per lavoro”. L’autogiustificazione è più comoda della verità.
E vale anche per il voto, oggi sempre più polarizzato. Se ho sostenuto un politico che si rivela inadeguato, ammetterlo non significa solo mettere in discussione lui. Significa mettere in discussione me stesso. Io mi considero una persona razionale, informata, consapevole. Com’è possibile che abbia sbagliato così tanto? Scatta il riflesso automatico: trovo scuse per giustificarlo. Perché, nel farlo, sto giustificando me stesso. E, magari proprio per questo, lo voto di nuovo.
La verità è che, per come siamo fatti, alleviare il disagio mentale conta più, nell’immediato, che affrontare il riscaldamento globale. Accettare che le nostre azioni contribuiscano alla crisi climatica significa ammettere qualcosa di sgradito: che facciamo parte del problema. Ed è una ferita narcisistica difficile da digerire.
Nel suo libro Living in Denial, la sociologa Kari Marie Norgaard ha indagato da vicino questa reazione psicologica. Lo ha fatto seguendo, durante un inverno anomalo, una comunità rurale norvegese ben informata, colta, attenta ai temi ambientali. Lì, la prima nevicata arrivò con due mesi di ritardo, la pesca sul ghiaccio fu cancellata e l’industria dello sci dovette ricorrere alla neve artificiale. I giornali parlavano apertamente di cambiamento climatico. Eppure nessuno scrisse lettere, nessuno fece pressioni sui politici, nessuno cambiò abitudini. Sapevano. Ma non agirono. Norgaard l’ha chiamata “negazione socialmente organizzata”: un sapere che, pur essendo presente e riconosciuto, resta scollegato dalla vita quotidiana. Non per ignoranza, disinteresse o malafede, ma per difesa emotiva. Un’anestesia collettiva che ci consente di convivere con l’intollerabile, permettendoci – come scrive – «di sapere e non sapere allo stesso tempo». È la descrizione di una rimozione profonda. Quella che può colpire anche le società più istruite e benintenzionate quando la realtà diventa troppo scomoda da affrontare. Non perché non la vediamo. Ma perché, in fondo, non vogliamo vederla.
Quando la realtà ci dice una cosa, e la nostra identità, le nostre abitudini o il nostro stile di vita ne dicono un’altra, qualcosa dentro si incrina. E per ricomporre quella crepa, cambiamo narrazione.
Ecco perché il negazionismo climatico, prima ancora che ideologico e politico, è un fatto psicologico. Una forma di dissonanza cognitiva su scala planetaria. Solo che, questa volta, la posta in gioco non è più soltanto la coerenza con noi stessi, ma la sesta estinzione di massa causata dal nostro stile di vita.
Il testo dell’articolo è tratto da Scongeliamo i cervelli, non i ghiacciai, Solferino libri, in uscita il 19 settembre












