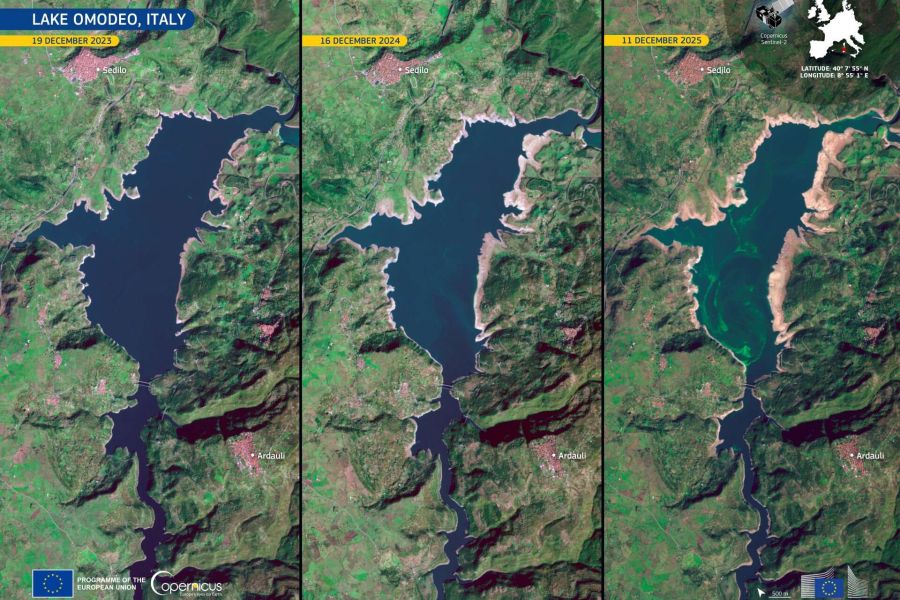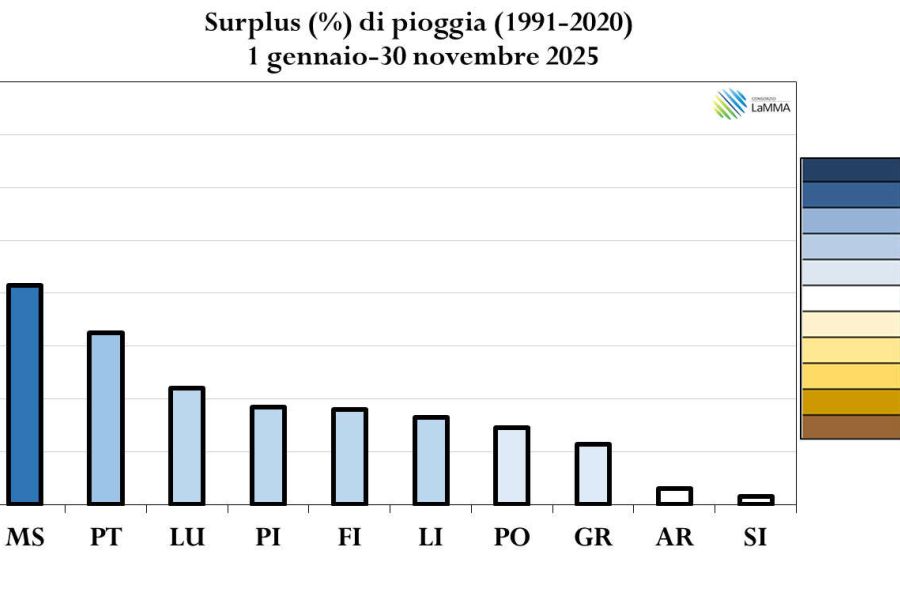Servizio idrico, in Italia 42 concessioni in scadenza ma investimenti attivabili per 5,5 miliardi di euro

Il Servizio Idrico Integrato in Italia si trova ad affrontare una transizione, in cui la necessità di migliorare la qualità del servizio e ridurre gli impatti ambientali si scontrano con la sostenibilità economica e sociale della tariffa: sfide industriali e finanziarie che chiamano l’esigenza di un ulteriore consolidamento gestionale. La sostenibilità finanziaria è, infatti, al centro del dibattito di operatori e istituzioni di governo.
Questo sistema gestionale, oggi in evoluzione verso un assetto industriale più maturo, è ancora macchiato da due elementi di criticità, uno persistente, l’altro emergente.
Il primo riguarda la resistenza di alcuni territori ad abbracciare percorsi gestionali di efficienza, anche attraverso l’apertura a operatori qualificati.
Il secondo delinea quasi un paradosso per i territori più evoluti ove il fabbisogno di investimento è tale per cui la leva finanziaria attivabile mostra comunque il fianco. Limiti che invocano una accelerazione verso un consolidamento inter-ambito, se non a scala regionale.
Per avere un quadro più preciso del settore e con l’obiettivo di identificare dinamiche emergenti, elementi di forza da valorizzare e criticità da superare, il Laboratorio REF ha analizzato le performance dei primi 100 gestori idrici italiani (selezionati sulla base della popolazione servita). Il lavoro si è focalizzato sui principali indicatori impiegati nella valutazione del merito creditizio, con una metodologia sviluppata dal Laboratorio REF in collaborazione con CRIF Rating.
Come si è svolta l’indagine? I gestori sono stati classificati in cinque raggruppamenti, sulla base delle dimensioni e delle performance economico-finanziarie. In dettaglio, sono:
- Aggregatori: ottima posizione economico-finanziaria; la crescita del bacino di utenza rafforza le capacità di investimento
- Potenziali aggregatori: buona posizione economico-finanziaria; la crescita del bacino di utenza può essere neutrale sulle capacità di investimento
- Stand alone: posizione economico-finanziaria sostenibile ma meno efficiente delle prime due categorie o buona posizione economico-finanziaria ma bacino d’utenza contenuto. Beneficiano di un’eventuale aggregazione con altri soggetti
- Piccoli precari: posizione economico-finanziaria scarsa e insufficiente
- Piccoli insostenibili: posizione economico-finanziaria scarsa, inefficienti e insostenibili in assenza di provvedimenti ad hoc per ripristinare l’equilibrio finanziario; gestori con EBITDA Margin negative.
Questa segmentazione consente di osservare un’evoluzione del sistema verso una “selezione naturale” che premia le gestioni più efficienti e strutturate, e al contempo invita a superare quelle più fragili e meno strutturate.
Come è emerso dall’indagine? Rimandando al Position Paper per una trattazione in dettaglio, si ha che
dal 2019 al 2023, vi è stata una riduzione dei cosiddetti “Aggregatori” e una crescita dei soggetti che hanno maturato una solidità coerente con il mandato industriale a cui sono chiamati (i cosiddetti “Stand Alone”), segno di una maturazione organizzativa in parte indotta da shock esterni, come la pandemia e la crisi energetica, e in parte dalle sfide industriali che il settore è chiamato ad affrontare, che impongono un ripensamento degli assetti gestionali.
Parallelamente, si è osservato un miglioramento diffuso della redditività operativa, a fronte però di un incremento delle tensioni finanziarie, dovute principalmente alla contrazione delle disponibilità liquide e all’aumento dell’indebitamento netto. Sono i segni di un settore che, pur mantenendo una discreta capacità di generare valore, mostra segnali di affaticamento finanziario, soprattutto nei raggruppamenti intermedi, come quello dei Potenziali aggregatori.
In questo contesto, il consolidamento industriale diventa centrale. La frammentazione resta infatti il principale freno allo sviluppo, con oltre 500 gestori attivi e appena 65 affidamenti unici su 93 bacini previsti. Alcune proposte di riforma dell’articolo 147 del D.Lgs. 152/06 volte ad ampliare la platea delle gestioni “salvaguardate”, rischiano di compromettere il percorso.
Negli ultimi anni (2021-2024) il consolidamento delle gestioni è stato guidato dal perfezionamento degli affidamenti ai gestori unici d’ambito e dai processi di aggregazione, mentre in taluni casi si è assistito ad un allungamento delle concessioni vigenti.
Infine, bisogna ricordare che tra il 2025 e il 2028 saranno 42 le concessioni che andranno in scadenza, per un totale di quasi 1.200 Comuni serviti e oltre 11 milioni di abitanti residenti, per un importo del Valore Residuo cumulato di oltre 4,1 miliardi di euro. Una cifra considerevole che richiederà agli EGA di riferimento attente valutazioni sui percorsi da intraprendere per l’individuazione dei gestori unici d’ambito e il rilascio delle nuove concessioni (salvo eventuali prolungamenti).
Finanziamenti e bancabilità del settore
L’analisi degli indicatori di bilancio, ci ha permesso di valutare le condizioni di sostenibilità finanziaria delle prime 100 gestioni italiane, anche in termini di leva dell’indebitamento ancora attivabile alla luce del percorso intrapreso fino ad oggi sul versante degli investimenti realizzati e dell’evoluzione della dinamica tariffaria.
Secondo le nostre stime, il potenziale attivabile di nuovi finanziamenti, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, è quantificabile in quasi 5,5 miliardi, con 81 operatori in regola per poter accedere a finanziamenti aggiuntivi: un valore significativo, ma è ben ricordare che si tratta pur sempre di un montante equivalente ad una singola annualità di spesa per investimenti dell’intero sistema gestionale nel suo complesso.
Per quanto concerne la “bancabilità” del settore idrico si è visto come – a partire dal 2017 – i finanziamenti hanno registrato un deciso aumento, passando dagli oltre 600 milioni dello stesso anno ai circa 1,5 miliardi del 2019. Con l’avvento della pandemia da Covid-19, il clima di incertezza ha però frenato le erogazioni di capitali, in particolare da parte delle banche. I minori finanziamenti provenienti dagli istituti di credito sono stati almeno in parte compensati dalle risorse stanziate dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), le quali sono aumentate nel 2020 del 41% rispetto all’anno precedente. Nel quadriennio successivo (2021-2024) l’ammontare dei finanziamenti ha registrato un andamento irregolare: dopo il rimbalzo del 2021, con un aumento di oltre 300 milioni rispetto all’anno precedente, nel 2022 i finanziamenti si sono più che dimezzati per poi attestarsi su quasi 1,3 miliardi nel 2023; nel 2024, infine, il settore idrico ha ricevuto finanziamenti per quasi 900 milioni di euro.
Nell’arco di tempo considerato (2017-2024), il volume complessivo di finanziamenti per il settore idrico italiano ammontava a circa 8,7 miliardi. Sebbene la quota parte degli stessi erogati dal sistema bancario potrebbe essere sottostimata, i dati mostrano come la principale forma di finanziamento sia rappresentata dall’emissione di bond (circa il 42% del totale), seguita dai finanziamenti della BEI (34%) e dalle banche (23%).
Nuove forme di finanziamento e Partenariato Pubblico-Privato
In ogni caso, nonostante la riforma varata dalla legge Galli ambisse a rendere il settore idrico finanziariamente autonomo attraverso lo strumento della tariffa, la finanza pubblica ha continuato a rivestire un ruolo rilevante, in particolare negli ultimi anni con il PNRR e React UE. Benché il livello delle tariffe in Italia sia ancora oggi di molto inferiori a quelle applicate nei principali Paesi europei, l’elevato fabbisogno di investimenti richiesto dal settore rischia di rendere insufficienti le risorse ottenibili tramite il mercato del credito, imponendo la valutazione di strumenti alternativi oltre ad un ruolo comunque integrativo e costante della finanza pubblica.
Di contro, i ben noti vincoli sulle finanze pubbliche hanno posto al centro della discussione la necessità di pensare a modalità di erogazione della spesa alternative al tradizionale modello del contributo a fondo perduto, valutando l’opportunità di percorrere una via intermedia tra la finanza pubblica e il ricorso al mercato finanziario, quale quella dei cosiddetti schemi finanziari “misti”, nei quali il ruolo dello Stato non è tanto quello di contribuire direttamente al finanziamento degli interventi, ma di fornire garanzie adeguate.
Seguono questa logica i cosiddetti strumenti finanziari “blended”. Si tratta di canali finanziari di tipo commerciale, nel senso che i finanziamenti devono essere comunque rimborsati, ma la presenza di opportune garanzie pubbliche e una precisa delimitazione dei rischi li rendono appetibili, ad esempio, da parte dei soggetti istituzionali (quali fondi sovrani o fondi pensionistici pubblici).
Infine, lo Stato dovrebbe adoperarsi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di finanziamenti nel settore idrico attraverso intermediari specializzati in grado di facilitare la predisposizione di progetti ben preparati e bancabili.
In attesa che il legislatore possa valutare l’affiancamento di strumenti finanziari innovativi con il sostegno della mano pubblica, con il nuovo metodo tariffario MTI-4, l’Autorità ARERA ha aperto la possibilità per i gestori di avvalersi di fattispecie di finanziamento attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi, sia finanziari che industriali. Fattispecie che, tra l’altro, vedrebbero maggiormente coinvolti i gestori medio piccoli, in gran parte ad assetto societario pubblico, i quali potrebbero beneficiare di modelli di collaborazione con qualificati operatori privati per la costruzione e la gestione delle infrastrutture idriche. Si tratta, in particolare, del cosiddetto partenariato pubblico-privato (PPP), uno strumento con il quale valutare in particolare il perseguimento dei nuovi obiettivi imposti dalla normativa comunitaria (es. la neutralità energetica nel segmento della depurazione introdotta con la nuova Direttiva Acque Reflue) e dalla regolazione ARERA in tema di mitigazione e decarbonizzazione del settore idrico (es. efficientamento energetico in senso stretto e incremento dell’autoproduzione da fonti rinnovabili per autoconsumo), agevolando anche l’adozione di tecnologie innovative e la digitalizzazione del settore.
In Italia, questo tipo di partenariato è regolato da un quadro normativo che integra leggi nazionali ed europee, al fine di assicurare la sostenibilità, l’accessibilità e la qualità dei servizi. Il PPP può rivelarsi utile anche per gestori di dimensioni medie o grandi in diverse circostanze: ad esempio quando la componente tecnologica è rilevante e il gestore non dispone internamente di tutte le competenze necessarie per gestirla adeguatamente; quando il progetto è multidisciplinare (ad esempio ricomprendendo anche l’installazione di impianti fotovoltaici, efficientamenti della depurazione o l’uso di piattaforme digitali, ecc.) e quindi la sua progettazione risulta complessa o difficilmente gestibile internamente; quando le fasi di permitting sono particolarmente articolate; quando si intende anticipare i benefici di un investimento che troverebbe copertura tariffaria troppo dilazionata nel tempo.
Il PPP presenterebbe diversi vantaggi, tra i quali un incremento dell’efficienza operativa che il soggetto privato qualificato può apportare grazie alla esperienza maturata sul campo in altri contesti, una maggiore disponibilità di capitale, grazie all’apporto di risorse finanziarie difficilmente reperibile in modo autonomo dal gestore, in particolare nei casi in cui la leva del debito sia stata esaurita, e una maggiore spinta all’innovazione attraverso l’introduzione di nuove tecnologie che possano migliorare la qualità e l’efficienza del servizio. A questi si aggiunge anche il tema del rischio, in quanto con il PPP il gestore passa al proponente gran parte del rischio di successo dell’investimento.
a cura di Donato Berardi, Francesca Casarico, Samir Traini, Cosimo Zecchi