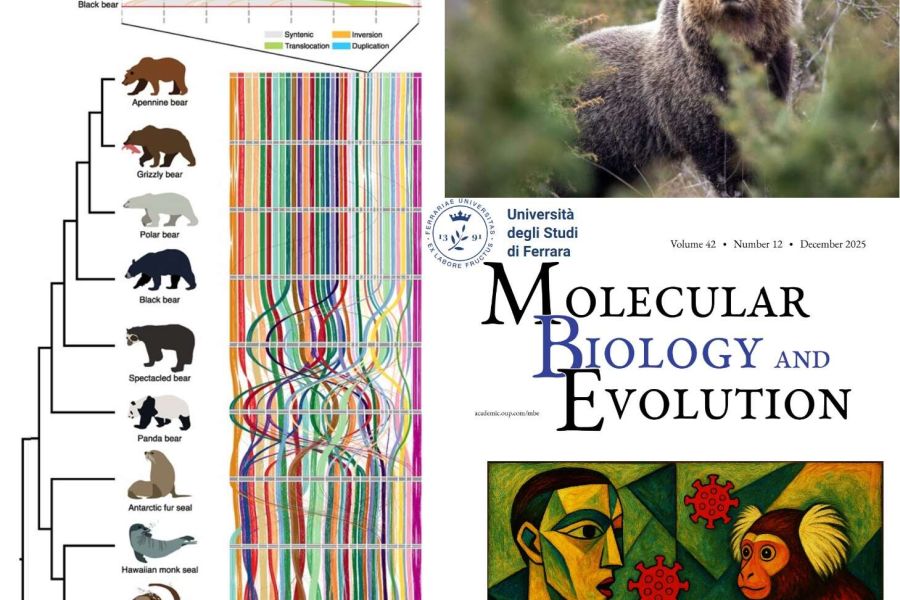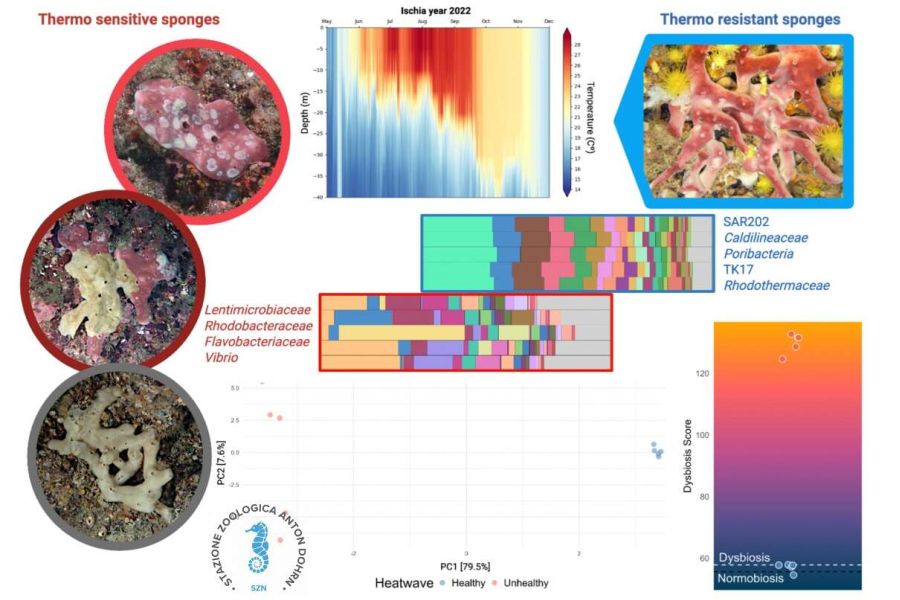L’idroelettrico è sostenibile solo se prevede la tutela degli ecosistemi

Recenti cronache hanno riportato la notizia della realizzazione di impianti di produzione idroelettrica, sottolineando la soddisfazione manifestata dagli Amministratori toscani che ne enfatizzavano la fonte rinnovabile e la sostenibilità. Si parlava di centrali ad acqua fluente, realizzate su briglie esistenti, costruite in passato per fornire energia agli opifici o per mitigare la forza erosiva del fiume, costretto a scorrere in ambito urbano. Non si può che essere d’accordo sul fatto che l’acqua corrente costituisca una risorsa rinnovabile (finché Natura vorrà, compresi i cambiamenti climatici) e quindi utilizzabile come tale anche dalle future generazioni. Ed è anche vero che utilizzare infrastrutture esistenti, come le briglie sull’Arno, sia un compromesso che minimizza l’impatto sia sulla quantità che sulla qualità della risorsa.
Ma attenzione, perché nella maggior parte dei casi l’uso dell’acqua, per fini energetici o altro, prevede di derivarla, cioè sottrarla alla naturale portata del fiume e quindi anche alle comunità che lo popolano, rappresentate da pesci, anfibi, macroinvertebrati e una grande varietà di organismi vegetali. Tutte forme di vita che si sono adattate alle variazioni periodiche di portata, agli spazi creati e modificati dalle dinamiche fluviali, alla complessa diversità ambientale su cui calibrano i loro cicli vitali. Per questo la normativa di settore, raccomandando di “perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili” chiede di “mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate”. Quindi interpretando il concetto di sostenibilità con la tutela degli ecosistemi.
La sottrazione di portata può incidere direttamente sul corso d’acqua o indirettamente tramite l’emungimento in falda. Quest’ultimo, più subdolo, può celare gli effetti che ricadono sulla portata del fiume. Infatti, nelle piane alluvionali, dove l’alveo scorre in stretta connessione con la tavola freatica, il prelievo eccessivo può provocare periodiche secche. È il caso in cui cade la sostenibilità e vengono meno i dettami della normativa.
La priorità dell’uso sostenibile e rinnovabile per le acque potabili, previsto dalla normativa, fa erroneamente tralasciare il rispetto per gli ecosistemi privati dell’acqua e induce a ometterne anche il minimo rilascio. La crescente richiesta di acqua, sia per soddisfare l’incremento demografico che le esigenze legate a stili di vita tutt’altro che morigerati, fa sì che il gestore del servizio idrico sia più propenso alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, piuttosto che a incentivare un uso moderato della risorsa. Le acque luride, seppur depurate, vengono rilasciate a notevole distanza dalla fonte, spesso direttamente in mare, impoverendo così tutti i sistemi idrici intermedi. L’idropotabile è certamente indispensabile per l’uomo, ma è un uso sostenibile?
Pensando agli usi irrigui o a quelli industriali, anch’essi basati sul consumo della risorsa, si fa difficoltà a concepire l’equivalenza tra rinnovabile e sostenibile. In entrambi questi casi parte dell’acqua utilizzata può tornare al corpo idrico di provenienza, ma in genere modificata nella sua composizione chimica. Nel caso dell’irriguo poi si giunge al paradosso che la richiesta di acqua è spesso in stridente contrasto con la sua disponibilità essendo maggiore quando questa scarseggia.
Quasi sempre sottovalutate, le derivazioni ad uso produttivo possono incidere sulla regimazione idrica e sulla qualità delle acque. Specie se i quantitativi derivati superano la capacità auto depurativa di un corso d’acqua, che varia in funzione della portata. Se poi è estratta dal sottosuolo, con eccessivo sfruttamento della falda, si può ripetere il rischio di secca totale.
L’acqua derivata è utilizzata e rilasciata a valle dell’insediamento produttivo. Essa oltre a variare nelle sue caratteristiche qualitative, può diminuire per assorbimento ed evaporazione. Se poi viene inviata a un sistema centralizzato di depurazione, può accadere che non torni più, non solo allo stesso fiume, ma neppure al medesimo bacino imbrifero in cui è stata prelevata.
L’uso idroelettrico, a cui più si addice il termine di energia da fonti rinnovabili, prevede la realizzazione di dighe e traverse che danno origine a laghi artificiali: l’acqua viene derivata sistematicamente dai tratti più elevati del bacino per essere raccolta negli invasi principali. Tramite un sistema di condotte, si produce energia idroelettrica senza che l’acqua ritorni negli alvei. L’acqua utilizzata percorre distanze chilometriche, per giungere ad altri invasi posti a valle nel bacino e così via. Questo trasloco attraverso il bacino può provocare una carenza cronica di acqua nella gran parte dei tratti fluviali.
Il sistema di invasi fu concepito per assolvere una funzione strategica quando c’era fame di energia e l’assolvono tuttora come rifornimento idrico del territorio quando, nei periodi di magra, le portate calano sensibilmente. Gli invasi possono inoltre costituire un mezzo di difesa dalle piene, trattenendo gli eccessi di portata e restituendo gradualmente le acque raccolte quando il pericolo è cessato. Questi nuovi benefici non possono, tuttavia, rappresentare un elemento di sostenibilità e tantomeno di molteplicità in quando gli usi possono elidersi a vicenda.
Negli ultimi decenni si è assistito ad una enorme diffusione di derivazioni destinate alla produzione di energia idroelettrica, per centrali di modeste dimensioni (fino ad alcune centinaia di L/s). All’insegna dell’energia rinnovabile, l’acqua sottratta dal suo corso naturale viene trasferita a mezzo condotta forzata alle turbine, distanti anche alcuni chilometri dal punto di prelievo, dopo di che viene immessa nuovamente in alveo. In questi casi non si può parlare di derivazione da consumo e le concessioni si sono avvalse del compromesso dato dal deflusso minimo vitale, oggi sostituito da quello ecologico, che viene rilasciato nel tratto compreso tra la derivazione e il rilascio. Una quantità pur sempre inferiore alle condizioni originali di portata e soprattutto di regimazione naturale per le comunità acquatiche costrette ad un razionamento giornaliero a cui inevitabilmente si devono adattare per non soccombere.
Senza entrare nel merito degli impatti dati dalle infrastrutture sull’ambiente, data la breve narrazione di queste riflessioni, è facile capire che il naturale ciclo dell’acqua garantisce la risorsa rinnovabile ma non è detto che l’uso che se ne fa possa definirsi per questo sostenibile.