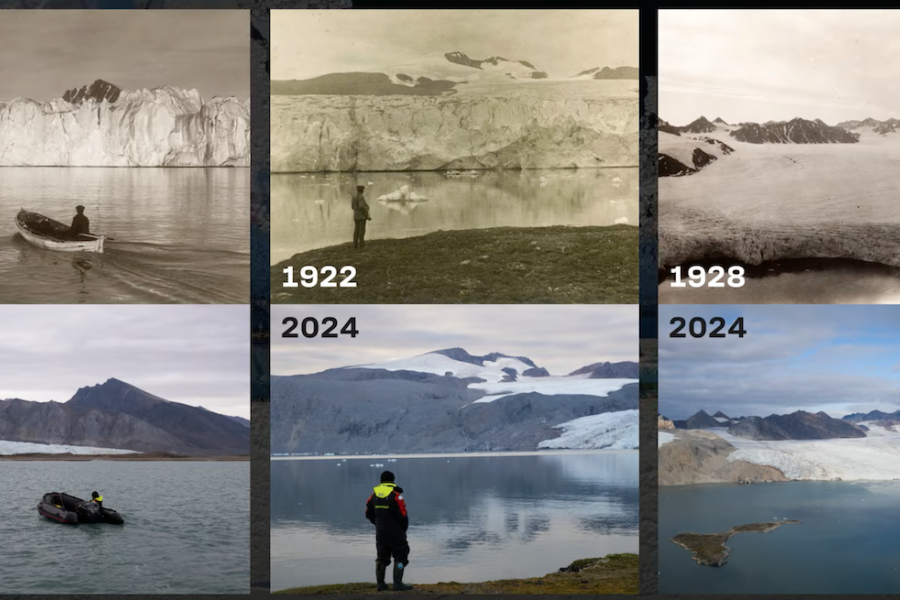Quando il clima diventa notizia: la tempesta delle parole

Piove. Eppure non basta più dirlo. Oggi “piove” non fa notizia: serve la “bomba d’acqua”, l’“ondata di maltempo”, “perturbazione record”. Ogni anno il lessico meteorologico si arricchisce di iperboli, e la comunicazione scivola su un terreno sempre più sdrucciolevole: quello dell’emergenza permanente.
Le parole con cui raccontiamo i fenomeni naturali plasmano la nostra percezione del rischio.
Se tutto è “imprevedibile”, se ogni pioggia è “straordinaria”, allora nessuno è davvero responsabile. Il linguaggio diventa uno scudo: sposta l’attenzione dal piano della prevenzione a quello della sorpresa. E così, stagione dopo stagione, la narrazione dell’evento sostituisce la riflessione sulle cause.
La comunicazione del rischio, invece, dovrebbe fare l’esatto opposto: accompagnare, spiegare, rendere consapevoli. Ma spesso la cronaca preferisce la spettacolarizzazione – il temporale diventa protagonista, la vulnerabilità dei territori un dettaglio. E il risultato è un Paese che si emoziona a ogni allerta, ma non si educa mai al rischio. La verità è che il cambiamento climatico non è un evento eccezionale, ma un contesto nuovo in cui viviamo.
Continuare a trattarlo come una notizia “shock” significa alimentare la percezione di impotenza collettiva. Le parole, in questo senso, non sono solo strumenti di racconto: sono strumenti di governo. Perché un linguaggio che parla sempre di “emergenza” finirà per farci dimenticare la parola più importante: “prevenzione”.
Forse dovremmo iniziare da qui – dal modo in cui ne parliamo – per costruire una cultura del rischio più matura, meno reattiva, più consapevole. Forse la vera emergenza non è quella meteo, ma quella culturale: imparare a nominare le cose per poterle finalmente governare.