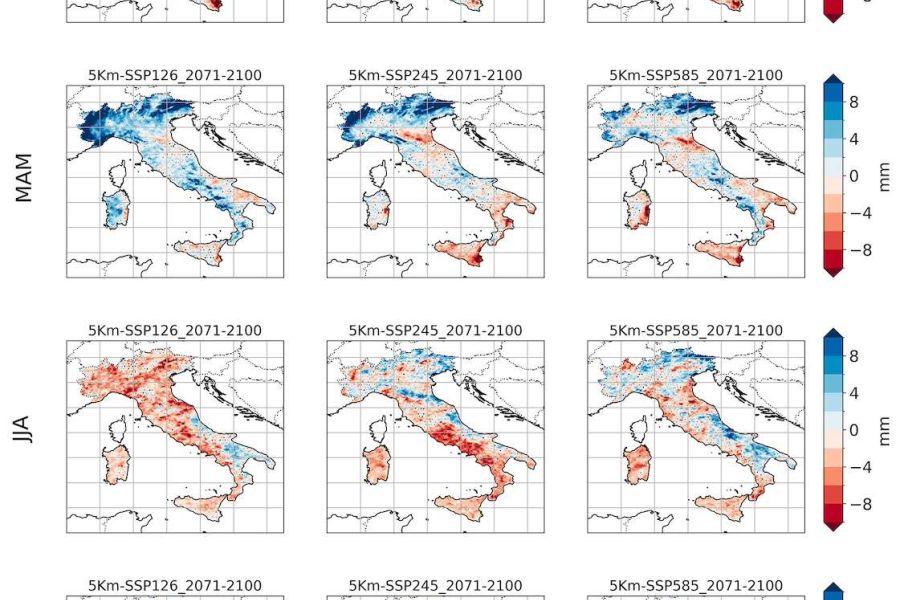Il prezzo invisibile del carbonio: ora col Cbam cambiano le regole del commercio globale
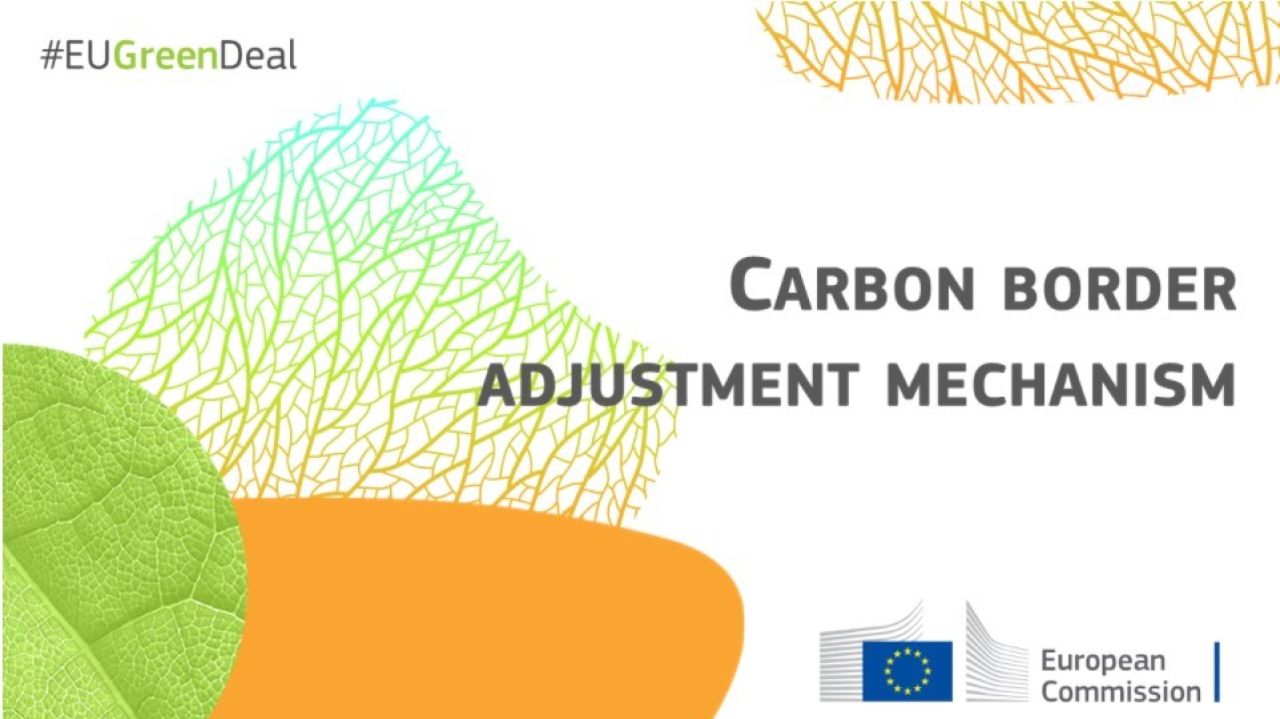
Fino a ieri quel costo non compariva da nessuna parte. Era nascosto nei fumi delle acciaierie, nei forni del cemento, nei processi chimici più energivori. Oggi, finalmente l’Europa ha deciso di dargli un nome e un prezzo. Dal 1° gennaio 2026 entra pienamente in vigore il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, la cosiddetta tassa sul carbonio importato. Una svolta che segna un passaggio storico: per la prima volta il commercio internazionale viene chiamato a fare i conti, davvero, con il cambiamento climatico.
La storia inizia qualche anno fa, quando ci si rende conto che le politiche ambientali rischiano di essere vanificate da un paradosso. Da un lato le imprese europee pagano per ogni tonnellata di CO₂ emessa, attraverso il mercato delle quote di emissione. Dall’altro, prodotti identici arrivano dall’estero a prezzi più bassi perché fabbricati in Paesi dove il carbonio non costa nulla. Il risultato? È duplice: concorrenza sleale e delocalizzazione delle emissioni. Le fabbriche si spostano, così si chiudono le aziende in italia e l’inquinamento resta.
È per contrastare questa falla che nasce il Cbam. Il meccanismo è tecnico e politicamente esplosivo: chi importa in Europa determinati beni dovrà dichiarare quanta anidride carbonica è stata emessa per produrli e acquistare certificati equivalenti, allo stesso prezzo pagato dalle industrie europee. Acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno sono i primi settori coinvolti: quelli più energivori, quelli che più pesano sul clima.
Dietro i numeri c’è una scelta precisa. Dare un valore economico al carbonio significa riconoscere che l’atmosfera non è una discarica gratuita. È un principio sostenuto dalla comunità scientifica da decenni: se i costi ambientali restano invisibili, il mercato continuerà a ignorarli. Se invece diventano parte del prezzo finale, cambiano gli incentivi, le tecnologie, gli investimenti.
Non tutti applaudono, certo, molti Paesi extraeuropei vedono nella nuova tassa una barriera commerciale mascherata. Ma è un inizio per difendere le nostre imprese da una concorrenza sleale. Si deve andare avanti, rivendicando una logica di equità: chi vende sul mercato europeo deve rispettarne le regole.
La vera scommessa, però, guarda oltre le dogane. Il meccanismo dovrebbe innescare un effetto domino: spingere tutti i Paesi a introdurre sistemi di prezzo del carbonio, rendere più conveniente investire in produzioni pulite, accelerare l’innovazione industriale. In altre parole, trasformare una tassa in una leva di cambiamento.
In fondo lo ripetiamo da anni, è quello che ci raccontiamo nelle Cop, le conferenze sul clima.
Il carbonio, per anni, è stato il grande assente dai bilanci economici. Dal 2026 non lo sarà più. E questa è una misura fiscale del vero cambiamento.
Un bel racconto, dal punto di vista scientifico, attribuire un prezzo al carbonio è uno strumento riconosciuto per ridurre le emissioni, ma da solo non basta. Senza politiche industriali coerenti, investimenti pubblici e una riduzione reale della domanda di materiali ad alta intensità energetica, il rischio è che la tassa si trasformi in un’operazione contabile più che in una svolta climatica.
Per le Pmi italiane il meccanismo può rappresentare sulla carta, un vantaggio competitivo, come abbiamo detto, perché le piccole e medie potrebbero non subire più la concorrenza di prodotti extra-Ue a basso costo ambientale. In questo senso, si riduce il dumping climatico e si riequilibra i prezzi, premiando chi ha già investito in tecnologie meno emissive. Tuttavia, il beneficio non è automatico: molte Pmi rischiano di essere colpite indirettamente dall’aumento dei costi delle materie prime importate.
Le associazioni degli industriali hanno più volte segnalato il rischio di un aggravio burocratico, di tensioni commerciali con i Paesi partner e di un impatto negativo sulle catene del valore. Senza una strategia industriale europea solida e senza adeguate compensazioni, il meccanismo rischia di diventare un costo aggiuntivo per le imprese più che uno strumento efficace di transizione ecologica.
Insomma, appare come un’arma a doppio taglio. Da un lato può ridurre la concorrenza sleale di prodotti importati a basso costo ambientale, spesso realizzati in Paesi dove energia e regole climatiche pesano molto meno sui bilanci. Per molte piccole imprese manifatturiere, già sottoposte a standard europei stringenti, questo potrebbe tradursi in condizioni di mercato più eque. Dall’altro lato, però, resta forte la preoccupazione per l’aumento dei prezzi delle materie prime e dei semilavorati importati, costi che difficilmente le Pmi riescono a scaricare sul cliente finale. Senza sostegni mirati e una reale politica industriale, il rischio è che la transizione venga pagata soprattutto dagli anelli più deboli della filiera.