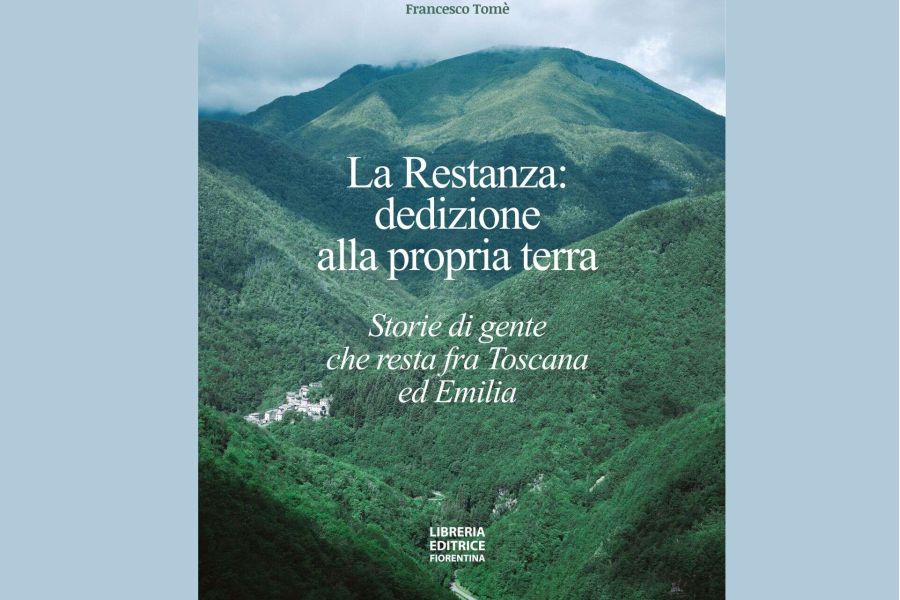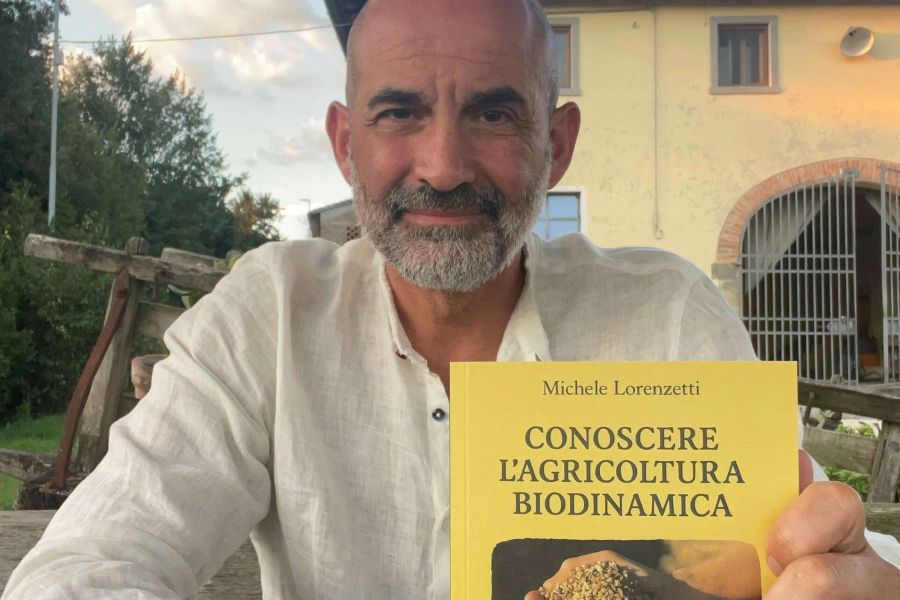Superare le sindromi Nimby e imparare dalla Cina: ecco come fare impresa nelle rinnovabili

Oggi è una società benefit, tra le maggiori protagoniste della transizione ecologica in Italia – con attività anche in Cina, Brasile e Colombia –, ma nel 1995 il fondatore ebbe difficoltà anche solo a spiegare al suo notaio cosa avrebbe realizzato la nuova azienda. È la parabola di Asja Energy, che quest’anno ne compie trenta e grazie al suo presidente Agostino Re Rebaudengo è oggi in grado di produrre energia rinnovabile per 1 milione di persone.
Intervista
Quel giorno dal notaio, trent’anni fa, si aspettava che la sua Asja potesse crescere fino a questi livelli?
«Allora non pensavo a cosa sarebbe successo nel 2025, ma se da un lato sono convinto che se mi fossi concentrato maggiormente sull’azienda avrebbe potuto crescere ancora di più, dall’altro credo che sia importante – anche come imprenditore – avere più punti di focalizzazione. Oggi conto una ventina d’anni di militanza nel mondo dell’associazionismo d’impresa, passando da Aper ad assoRinnovabili, da Confindustria Energia a Elettricità Futura; sono stato per 11 anni presidente del Teatro Stabile di Torino, altro tempo l'ho dedicato come presidente e oggi come socio al Museo A Come Ambiente; al CinemAmbiente Film Festival. E ovviamente per me importantissimi sono anche i 30 anni di lavoro e di successi della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per l'arte contemporanea guidata da mia moglie Patrizia Sandretto. Partecipo anche alla Venice Garden Foundation per il restauro, la cura e la conservazione dei beni artistici e culturali di Venezia tra cui l’avvenuto recupero dei Giardini Reali e degli Orti del Santissimo Redentore, un bellissimo progetto guidato da mia sorella Adele.
Credo sia molto importante dedicarsi al lavoro e alla propria azienda, cosa che faccio con passione, ma i risultati non si misurano solo in fatturati o kWh prodotti. Senza di essi non potrebbe forse esserci tutto il resto, ma se una persona ne ha le possibilità credo sia suo dovere dedicare tempo a migliorare le cose che ha intorno a sé».
Il mecenatismo come un dovere dunque, più che un piacere?
«Sì, ma anche come un’opportunità. Dobbiamo lavorare per far funzionare bene l’impresa in cui abbiamo delle responsabilità, ma le altre attività credo aiutino ad avere una visione più ampia delle cose. È la metafora del salire sull’elicottero che mi hanno insegnato all’Harvard Business School, per guardare dall’alto e avere così il quadro della situazione: ti aiuta a definire meglio gli obiettivi da raggiungere, e permette d’individuare le strade migliori da prendere, che non sempre sono le più corte».
Era più dura nel 1995 o oggi fare impresa nel comparto delle rinnovabili?
«A mio parere nel ’95 c’erano più opportunità, perché si era per certi versi all’inizio e con meno competizione, ma anche oggi sul fronte applicativo c’è ancora moltissimo da fare, c’è spazio per crescere: pensiamo anche solo all’Europa, dove la produzione di elettricità da rinnovabili è oggi di poco inferiore al 50% e dovrà largamente superare l’80% in pochi anni, e al contempo dovremo efficientare grandemente l’impiego dell’energia. Penso ad esempio ai data center: la narrazione mainstream è quella dell’intelligenza artificiale che consuma tantissima energia, ma è solo parzialmente vero, perché questa tecnologia se sarà usata come dovrebbe ci permetterà di ottimizzare l’efficientamento tanto da portare a multipli di minor consumo. Lo stesso vale per l’auto elettrica, che ha un’efficienza di conversione superiore all’80% mentre quella del motore termico si ferma attorno al 30%».
Che consiglio si sentirebbe di dare a un nuovo imprenditore che si affaccia adesso nel comparto?
«Evitare l’approccio dell’abbiamo sempre fatto così. Da sempre in Asja, proprio come metodo, ogni tre anni rimetto in discussione tutto quello che facciamo; è un’abitudine che ho preso fin dai miei primi lavori, ogni triennio cambiavo e anche oggi per me è un’unità di misura importante per rimettere in discussione il punto di vista. A chi inizia oggi direi di disegnare la propria azienda guardando avanti, immaginarsi cosa succederà nei prossimi 3-5 anni, studiare bene quella prospettiva e sapere che se è stato razionale nella propria visione… non accadrà. Se l’approccio è razionale, l’esperienza insegna che le probabilità di avverarsi sono bassissime, quindi è necessario avere pronto un piano B; il risultato è che a quel punto saranno in pochi ad aver identificato lo scenario reale, non mainstream, ed è lì che si aprono le opportunità».
Oltre che in Italia, Asja lavora anche in Argentina, Brasile, Cina e Colombia. Trova differenze nell’approccio alle rinnovabili tra questi Paesi?
«In Cina l’approccio è molto pragmatico. L’energia elettrica è gestita da sette aziende ribattezzate le sette tigri, per avere un’idea della competizione feroce nel settore, ma gli obiettivi da conseguire si traguardano. Esistono delle regole da rispettare ovviamente, anche lì c’è un momento di confronto con gli enti pubblici, aspetti di negoziazione e quelli amministrativi, ma a un certo punto la burocrazia funziona e gli investimenti partono. In Brasile, Colombia e anche Italia c’è maggiore caos normativo, e anche nei momenti di confronto con l’ente pubblico le cose sono sempre più lente di come dovrebbero essere; in Argentina trovo sia ancora più difficile lavorare, è un Paese da cui siamo usciti dopo due anni di attività. Guardando alle similitudini nei tratti culturali, in Argentina ovviamente c’è molto dell’Italia e della Spagna, ma anche in Cina trovo ci sia una voglia di vivere e un’attenzione alle relazioni personali molto forti, così come l’interesse per la cultura. Sotto questo profilo, per molti versi Cina e Italia si assomigliano».
Nel nostro Paese le sindromi Nimby e Nimto sono tra i principali fattori di freno della transizione ecologica. Per la sua esperienza, quali dei due trova più difficile affrontare?
«Per la mia esperienza è peggiore il Nimto (Not in my terms of office, non nel mio mandato elettorale, ndr), perché in Asja abbiamo sempre dato molta importanza al confronto con le persone, coi territori e con le amministrazioni che li governano, anche attraverso lo strumento del dibattito pubblico. Le classiche sindromi Nimby (Not in my backyard, non nel mio giardino, ndr) che si presentano davanti a progetti per la realizzazione di biodigestori anaerobici, ad esempio, le abbiamo sempre superate tutte e anche con dei bei risultati: abbiamo coinvolto i comitati contrari agli impianti perché ci aiutassero strutturalmente a lavorare meglio, attraverso la loro sorveglianza. Quest’approccio oggi ci dà un grande vantaggio competitivo, perché quando partecipiamo a un bando di gara o ci presentiamo in un Comune, la prima cosa che fanno è andare su internet per vedere di che pasta siamo fatti, ci telefonano, approfondiscono. Alla fine ci riconoscono serietà, il non avere conteziosi aperti, e soprattutto il fatto che la gente di Asja fa quello che dice: dovrebbe essere la normalità, eppure è considerato un plus straordinario.
Invece la sindrome Nimto è quella di cui davvero soffre il settore, e comporta anche enormi costi aggiuntivi al sistema-Paese: si traduce nel complicare la legislazione, o nel non rispettare le tempistiche previste dalla normativa. Basti ricordare i risultati di uno studio Ambrosetti, per il quale potremmo liberare 150 miliardi di euro di Pil a costo zero, solo rendendo più efficiente la Pubblica Amministrazione. Perché sia chiaro: nessuno vuole un mondo senza regole, che sarebbe peggiore di quello attuale, ma l’attuale inefficienza amministrativa rappresenta un’enorme occasione persa per il nostro Paese, come storicamente mostra anche l’incapacità di spendere i fondi europei che ci vengono assegnati ogni anno, finanziati peraltro anche dal contribuente italiano».