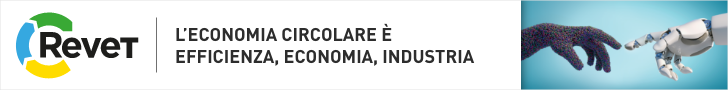Il Tuatara ha due genomi mitocondriali completamente funzionali e profondamente divergenti

Lo studio “Evidence of two deeply divergent co-existing mitochondrial genomes in the Tuatara reveals an extremely complex genomic organization”, pubblicato su Communications Biology da un team internazionale di ricercatori guidato da Robert Macey del Peralta Genomics Institute ha scoperto un’organizzazione genomica estremamente complessa nel Tuatara (Sphenodon punctatus), il rettile in estinzione col “terzo occhio” che viveva già al tempo dei dinosauri ma che oggi sopravvive solo in Nuova Zelanda.
Il Tuatara Ricercatori come Macey ei suoi colleghi sono attratti dalla A causa delle sue sorprendenti caratteristiche, tra le quali la longevità e un'insolita combinazione di aspetti morfologici simili a quelli dei rettili e degli uccelli che rendono difficile collocarlo su un ramo dell’albero dell’evoluzione, il Tuatare ha sempre attirato l’attenzione degli scienziati che lo sescrivono spesso come un “fossile vivente”, una specie che ha avuto un’evoluzione molto lenta e che conserva ancora caratteristiche di antichi antenati.
Uno dei co-autori dello studio, Neil Gemmell, è stato il principale autore dello studio “The tuatara genome reveals ancient features of amniote evolution”, pubblicato su Nature nell’agosto 2020, aveva già rivelato che «Il tuatara ha un'architettura genomica diversa da qualsiasi cosa precedentemente riportata, con un amalgama di caratteristiche che precedentemente erano state considerate come caratteristici dei mammiferi o dei rettili. Inoltre, sono davvero belli».
Per analizzare il DNA del Tuatara, in particolare il genoma mitocondriale, Macey e il suo team hanno utilizzato una varietà di tecniche, comprese le tecnologie di sequenziamento del DNA a lettura breve e lunga . I dati sono stati valutati in collaborazione con scienziati austriaci e della Smithsonian Institution , con la tecnica Oxford Nanopore, sequenziamento di PacBio e il sequenziamento di Sanger e utilizzando database come NIH Sequence Read Archive (SRA) e GenBank.
Al Peralta Genomics Institute sottolineano che «I risultati sono stati sorprendenti: è stato scoperto che un individuo Tuatara di Lady Alice Island aveva due genomi mitocondriali distinti». IL patrimonio genetico scoperto è qualcosa che si triva nei molluschi bivalvi ma non nei vertebrati e i ricercatori evidenziano: «La scoperta di due genomi mitocondriali profondamente divergenti nel Tuatara ha profonde implicazioni per la nostra comprensione dell'organizzazione, dell'ereditarietà e dell'evoluzione del genoma mitocondriale animale».
Il Tuatara Genome Project è in corso da diversi anni e quest’ultimo studio rappresenta una svolta significativa. Come spiega lo Smithsonian Magazine, «Tutti gli animali hanno DNA nucleare che si trova nel nucleo della cellula e DNA mitocondriale, situato nella cosiddetta "centrale elettrica" cellulare, i mitocondri. Esaminando entrambi i tipi di genomi, gli scienziati stanno costruendo immagini dell'evoluzione di innumerevoli specie nel corso dei millenni». Una delle autrici dello studio, Ella Buring, ex stagista Global Genome Initiative (GGI)allo Smithsonian’s National Museum of Natural History, aggiunge: «Se conosci i trucchi matematici giusti, puoi trovare una storia evolutiva nascosta in una discarica di dati. Sono stato molto attratta dall'idea che il passato racconti una storia, se solo sai come analizzarla nel modo giusto». Ma la scoperta del suo team di un secondo genoma mitocondriale complica il racconto evolutivo del Tuatara.
La Buring e Vanessa González , una scienziata che si occupa di genomica computazionale alla GGI, hanno analizzato le sequenze di DNA dei Tuatara le hanno confrontate con altri DNA di rettili. Ben presto si sono rese conto che il genoma non era così incompleto come inizialmente pensavano gli scienziati e andando avanti hanno scoperto troppe sequenze misteriose di DNA nel genoma mitocondriale del Tuatara.
Un altro autore dello studio, Daniel Mulcahy della GGI e della Smithsonian Institution, racconta: «Abbiamo iniziato a scavare più in profondità e abbiamo finito per ricostruire un secondo genoma mitocondriale completo» che è risultato diverso per il 10% dal genoma mitocondriale "tipico" del Tuatara.
Allo Smithsonian sottolineano: «Sebbene la scoperta di un secondo genoma mitocondriale sia stata confermata solo in un singolo esemplare, la sua presenza è resta sorprendente. Se gli scienziati scoprissero che i doppi genomi mitocondriali sono comuni nei Tuatara, potrebbero usare questi genomi multipli per scoprire quando ogni genoma è apparso e quando si è separato dall'altro nel tempo. La ricerca potrebbe aiutare gli zoologi a capire cosa rende esattamente la specie così geneticamente diversa da tutti gli altri rettili».
Una scoperta eccezionale che ha visto protagonisti giovani scienziati e i loro formatori e Rebecca Johnson, direttore associato per la scienza e scienziata capo dello Smithsonian’s National Museum of Natural History, conclude: «Ora più che mai, la scienza, la tecnologia e il pensiero critico basato sull'evidenza sono essenziali per comprendere alcune delle maggiori sfide per il nostro pianeta. In qualità di custodi della più grande collezione di storia naturale del mondo, uno dei nostri ruoli più importanti al National Museum of Natural History è quello di formare la prossima generazione di scienziati e professionisti del museo».