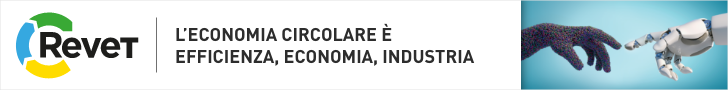Ecco perché le reti elettriche dominate dalle fonti rinnovabili non sono più fragili

Negli ultimi giorni il blackout spagnolo ha riportato alla ribalta il tema della transizione energetica. In un momento in cui si leggono le analisi di decine, forse centinaia di opinionisti molti dei quali, fino all' altro ieri, si professavano esperti di geopolitica o di epidemiologia, sembra essere opportuno fare un po' di ordine. Partiamo da cosa ancora non sappiamo.
Nonostante tutto non conosciamo ancora esattamente le cause blackout. Sono state avanzate varie spiegazioni, alcune più plausibili di altre, ma ad oggi il gestore della rete elettrica spagnola ha solo dichiarato che le indagini sono ancora in corso. La stessa matrice terroristica, per quanto da molti ritenuta improbabile, non è ancora completamente da escludere anche in quanto più di un'organizzazione ha rivendicato l'attentato.
In presenza di così tante incertezze, piuttosto che fornire ulteriori teorie su quale possa essere la spiegazione dell'evento senza avere a disposizione dati certi, penso sia più utile fare un riassunto di quello che invece sappiamo su eventi di questo tipo, e soprattutto su quello che può essere importante sapere in ottica delle scelte che si dovranno affrontare nei prossimi anni.
Innanzitutto sappiamo che, come ha ricordato Luigi Moccia (ricercatore Cnr), blackout come quello che si è verificato qualche giorno fa in Spagna non sono nuovi e soprattutto non si verificano soltanto in reti dominate da fonti rinnovabili. Alcuni esempi sono il blackout svedese del 2003, causato dall'interruzione improvvisa di uno degli impianti nucleari del paese, e quelli francesi del 1978, 1987 e 1999; senza dimenticare il blackout avvenuto in Italia nel 2003, causato dall'interruzione di una delle linee di trasmissione con la Svizzera.
A questo punto però sorge comunque la domanda se la presenza di grandi quantità di fonti rinnovabili, in particolare solare ed eolico, nella rete elettrica possa renderla più fragile rispetto ad avvenimenti come questi. La risposta a questa domanda è complessa.
Si è parlato molto in questi giorni del concetto di inerzia di una rete elettrica. Questa rappresenta la sua capacità di assorbire e gestire delle perturbazioni, come potrebbero essere una variazione improvvisa di produzione o richiesta di elettricità. Tradizionalmente, l'inerzia di una rete elettrica è garantita dalla presenza dei generatori delle centrali termoelettriche, come quelle a gas, carbone, e nucleare. Il fatto che l'inerzia fornita da questi sistemi sia, nella stragrande maggioranza dei casi, sovrabbondante rispetto alle esigenze ha fatto sì che la quasi totalità degli impianti eolici e fotovoltaici oggi installati non adottino soluzioni (quali i cosiddetti “grid-forming inverters”), che permettano loro di contribuire attivamente all’inerzia di rete. La rete spagnola, che negli anni ha visto l'installazione di grandi quantità di solare ed eolico senza però predisporre nel frattempo particolari aggiornamenti per migliorarne il controllo, durante il periodo del blackout risultava effettivamente più fragile dal punto di vista dell’inerzia rispetto a reti dominate da fonti convenzionali.
Questo però non vuole necessariamente dire che reti elettriche dominante da fonti rinnovabili non programmabili siano necessariamente più fragili. Un elemento infatti che contribuisce fortemente alla stabilità di rete e che sarà necessariamente presente in quantità infuture reti dominate dalle rinnovabili sono le batterie. Ci sono già numerosi esempi, verificatisi in reti, come quella del Regno Unito, dove la quantità di accumuli elettrici installati è maggiore, in cui la presenza di batterie connesse alla rete ha permesso di evitare blackout causati da situazioni che il sistema non sarebbe stato altrimenti in caso di gestire. Proprio in Regno Unito, è infatti già successo due volte che le batterie hanno salvato la baracca: nel 2019, in occasione della disconnessione imprevista di due centrali distinte, e nel 2024, quando si è improvvisamente interrotta la connessione con il continente. Questo non è un caso: mentre in Italia al 31 dicembre 2023 erano installati soltanto 0.2 GW di accumuli di rete, nel Regno Unito ve ne erano 3.5 GW, quasi 20 volte tanto. In Spagna, nel momento del blackout, c’erano 60 MW. Troppo pochi, come hanno fatto notare dall’Australia meridionale; lì infatti, in una rete semi isolata dove da anni solare ed eolico la fanno da padrone (75% della domanda nel 2023, in media), sono presenti molti più accumuli elettrici (poco meno di 1 GW, ma per una rete molto più piccola di quella spagnola), e non sono stati registrati blackout negli ultimi anni.
Gli accumuli elettrici non rappresentano qualcosa di aggiuntivo o imprevisto: la loro necessità per compensare momenti di bassa produzione di energia in reti dominate da fonti rinnovabili non programmabili è nota. Le stime variano a seconda della fonte, dai 17 GW del rapporto commissionato dal think tank Ecco climate ai quasi 100 GW ipotizzati da Zollino e dagli scenari più conservativi osservati dai ricercatori della Università la Sapienza di Roma: in ogni caso, più che a sufficienza per gestire situazioni simili a quanto visto in Spagna e Portogallo in questi giorni.
Attenzione: il punto del discorso non è che una transizione a sistemi 100% rinnovabili sarà una passeggiata o qualcosa che avverrà a costo zero: Terna prevede costi di adattamento della rete elettrica di 23 miliardi di euro da qui al 2034, ai quali ne andranno aggiunti circa altrettanti per i quasi 100 GWh di accumuli elettrici che, secondo Terna, saranno necessari per il giusto bilanciamento del sistema. È difficile oggi stimare il totale dei costi al 2050, ma ne serviranno verosimilmente almeno tanti quanti previsti da oggi al 2034. Il punto in questione è che nulla di tutto questo è impossibile, o ha costi fuori scala: gli accumuli serviranno anche a garantire inerzia di rete in un sistema dominato da rinnovabili non programmabili, e questa esigenza non richiederà quindi un aumento dei costi di adattamento del nostro sistema elettrico rispetto a quanto già previsto.
Concludere che i recenti eventi dovrebbero spingerci a rallentare sulle energie rinnovabili sarebbe quindi un errore, come hanno commentato tanto il premier Sanchez quanto il gestore della rete elettrica spagnola. In attesa di ulteriori chiarimenti riguardo quanto sia successo davvero, l'unica vera certezza che abbiamo è che, mentre continuiamo ad aumentare gli investimenti sulle fonti di energia rinnovabili (una scelta necessaria se si vogliono rispettare gli impegni sulle emissioni cumulate dell'Ue al 2050, come mostrato dagli studi dello European Scientific Advisory Board on Climate Change) è fondamentale che seguano di pari passo investimenti su sistemi ausiliari, necessari affinché il sistema elettrico risulti affidabile quanto quello odierno.