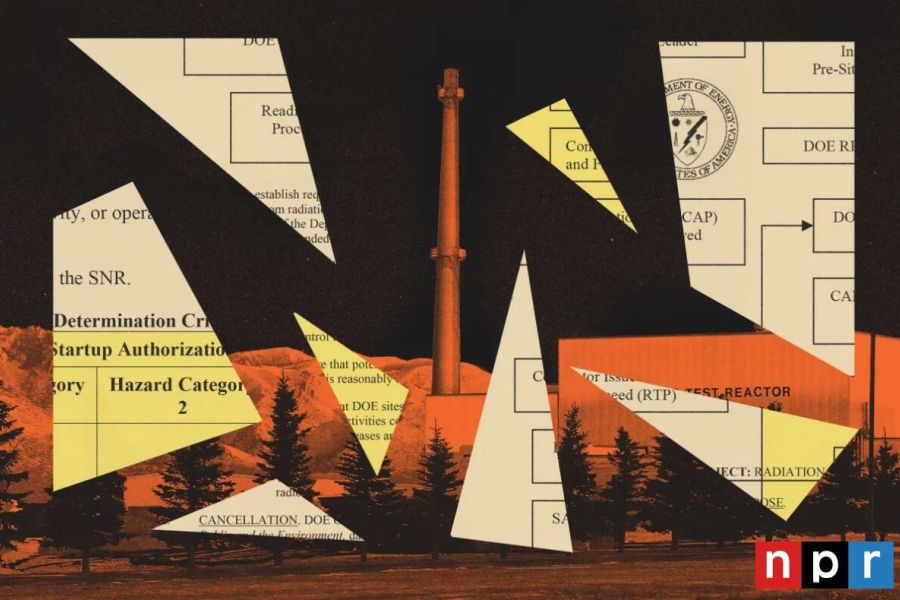Pericolosi livelli di Pfas rinvenuti in vini italiani. Greenpeace: serve una legge che vieti queste sostanze

Non solo nel cibo o nell’acqua. Anche in diversi tipi di vino sono stati rintracciati Pfas, “sostanze chimiche perenni” utilizzate in molti tipi di industria e dannose per la salute umana. A rivelarlo è un nuovo studio dal titolo “Message from the Bottle” pubblicato dal Pesticide action network (Pan Europe). In particolare, è stata rilevata la presenza di Tfa, ovvero l’acido trifluoroacetico, nei vini di dieci Paesi europei. Tra questi compare anche l’Italia: nello studio sono stati infatti analizzati dei campioni di Chianti, Prosecco e Kalterersee, dove sono stati riscontrati livelli di contaminazione giudicati preoccupanti.
Come denuncia Greenpeace, il timore è che «con il Tfa si stiano ripetendo gli errori del passato». Lo studio di Pan ha infatti esaminato 10 vini imbottigliati prima del 1988 e 39 vini recenti provenienti da 10 Paesi europei, Italia inclusa. In 45 delle 49 bottiglie analizzate è stata riscontrata la presenza del Tfa con livelli di contaminazione in alcuni casi addirittura 100 volte superiori a quelli riscontrati nell’acqua potabile. Nello specifico, i ricercatori hanno registrato nei vini recenti una concentrazione mediana di 110 microgrammi per litro (µg/l) e livelli di picco fino a 320 µg/l, record detenuto da un bianco austriaco del 2024. Tuttavia questi dati riguardano solo i vini recenti: nei vini più vecchi non è stata trovata traccia di PFAS.
Concentrando ancora di più lo sguardo sui vini italiani analizzati, una bottiglia di Chianti è risultata quella con il maggior livello di Tfa (120 microgrammi per litro), seguita dal Prosecco (69) e dal Kalterersee (43). I vini imbottigliati prima del 1988, invece, non presentano tracce di Tfa: un segnale chiaro di come l’uso dei Pfas, negli ultimi decenni, sia aumentato in modo esponenziale.
Ma come arrivano queste sostanze chimiche nel vino? Lo spiega Helmut Burtscher-Schaden, chimico ambientale della Global 2000 che ha collaborato al report. I Pfas sono usati in molti dei fertilizzanti che vengono impiegati nella filiera agricola destinata alla viticoltura: è così che il Tfa raggiunge il prodotto finale – il vino – risalendo dalle radici della pianta fino all’acino d’uva. Non è privo di rischi, anche se minori, neppure il vino biologico: segno che il Tfa può diffondersi anche attraverso l’acqua, la pioggia o il suolo inquinato. In molti fertilizzanti l’utilizzo dei Pfas, compreso il Tfa, è aumentato drasticamente negli anni e oggi tutti i distretti in cui esistono grandi coltivazioni industriali devono fare i conti con il pericolo di contaminazione.
Per Greenpeace potremmo essere all’inizio di una storia già vista perché anche alcuni decenni fa non avevamo informazioni esaustive sui Pfas oggi noti per essere cancerogeni, ma ora sono numerosi gli studi scientifici che li collegano a gravi patologie: danni al fegato, problemi al sistema endocrino e alla tiroide, alterazioni del sistema immunitario, tumori ai reni e ai testicoli, infertilità e diabete. Le ultime evidenze parlano anche di rischi di insorgenza di patologie tumorali a causa dell’esposizione prenatale.
Lo scorso marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge urgente per abbassare i limiti dei Pfas nelle acque potabili e introdurre restrizioni per il Tfa. Tuttavia Il provvedimento deve ancora essere approvato dal Parlamento.
Si tratta di segnale importante, ma non ancora sufficiente, sottolinea Greenpece. Che aggiunge: «Abbassare i limiti dei PFAS nell’acqua potabile è importante ma non risolutivo: se vogliamo che l’acqua che beviamo e il cibo che mangiamo siano sicuri, servono scelte ancora più coraggiose. Serve una legge zero-Pfas che vieti del tutto la produzione e l’uso di queste sostanze pericolose. La salute delle persone non può più aspettare».