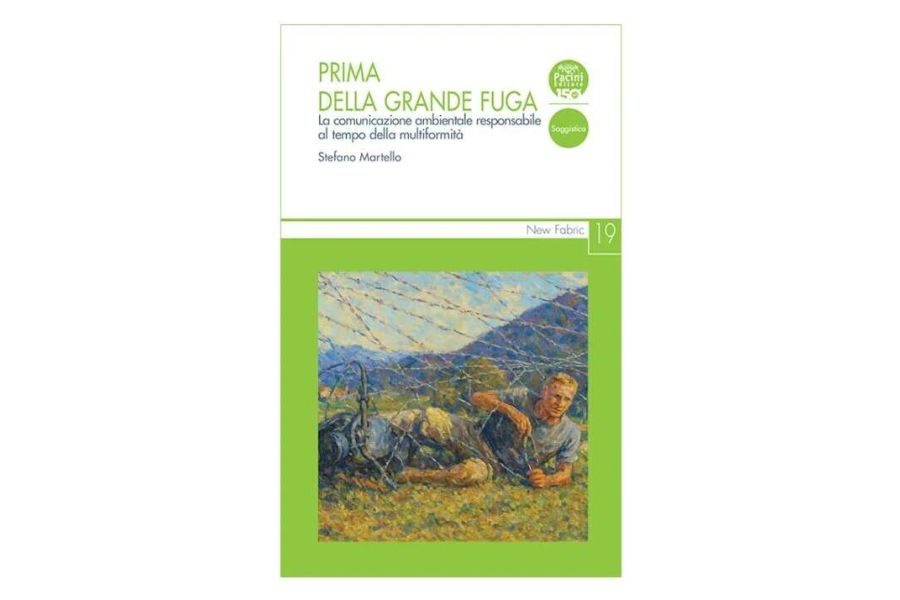È battaglia sul bilancio Ue: domani la proposta di von der Leyen, le lobby già calano su Bruxelles

Due mesi fa, alla Conferenza annuale 2025 sul bilancio Ue, Ursula von der Leyen ha annunciato sostanziali cambiamenti per il prossimo Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea. Quello attuale, ha detto la presidente della Commissione europea, «è stato progettato per un mondo che non esiste più, il mondo del 2020», mentre quello che andrà varato per il periodo 2028-2034 dovrà essere «flessibile, agile e reattivo» per intervenire dove necessario «rapidamente ed efficacemente». Ma ora, alla vigilia della proposta che dovrà presentare domani la Commissione Ue, vengono al pettine tutti i nodi che dovrà sciogliere Bruxelles, che ormai da tempo si trova a dover far fronte a una situazione geopolitica caratterizzata dall’aggressione della Russia ai danni di un Paese alle porte dell’Europa come l’Ucraina, l’aggressività delle politiche commerciali della Cina, l’offensiva di Donald Trump sui dazi, gli alti costi dell’energia e una crisi climatica che ha seri impatti anche sull’andamento dell’inflazione e causa l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari.
Se questo è lo scenario, le caratteristiche di flessibilità e agilità del prossimo Quadro finanziario pluriennale annunciate da Bruxelles per rendere più facile alle imprese europee l’accesso ai fondi comunitari rischiano di non essere all’altezza della sfida. La priorità è piuttosto intervenire sulla dimensione del bilancio. Ma quello che viene riferito da diversi osservatori sul campo è che la Commissione europea non sembra intenzionata a prendere in considerazione aumenti sostanziali rispetto all’attuale tetto di 1.200 miliardi di euro. La cifra è pari a poco più dell’1% del reddito nazionale lordo annuo dell’Ue, di contro a una percentuale che negli Stati Uniti, giusto per fare un paragone, si attesta a quota 23%. Senza spingersi fino a simili ipotesi, in un’analisi recente, il think tank Bruegel, specializzato in politiche economiche europee e globali, ha stimato che per colmare il gap d’investimenti da 800 miliardi di euro di cui ha parlato Mario Draghi in un rapporto tanto commentato quanto poco applicato, il prossimo bilancio pluriennale dell’Ue dovrebbe quasi raddoppiare (1,9%).
Ma anche questa più misera ipotesi suggerita da Bruegel di un aumento di circa lo 0,9% del reddito nazionale lordo annuo dell’Ue viene già data per esclusa, a Bruxelles. La Francia è tra i Paesi che si sono detti favorevoli ad aumentare il bilancio comunitario, ma la Germania ha già fatto sapere di non voler aumentare il proprio contributo. E poi ci sono gli Stati come l’Italia, alle prese con un debito pubblico che ha sforato i 3 mila miliardi di euro, o la Spagna (1.600 miliardi). Per non parlare di Paesi che neanche vogliono sentir parlare di mettere a disposizione ulteriori risorse nazionali per l’Ue, come l’Ungheria di Viktor Orbán.
Da dove possono arrivare eventuali nuove entrate per rimpolpare il bilancio dell’Europa? A Bruxelles riferiscono che è già in corso un acceso dibattito sull’ipotesi che possa essere ampliata la quota di entrate che le istituzioni comunitarie possono prendere dalle tasse o dagli accordi finanziari esistenti. Al centro della discussione c’è una bozza di nuovi prelievi o trasferimenti a livello Ue dalle entrate fiscali nazionali - noti come «risorse proprie» - per rimborsare dai 25 ai 30 miliardi di euro all’anno del debito emesso per finanziare la ripresa post-Covid. Ma nessuno è pronto a scommettere un centesimo sul fatto che l’unanimità o anche solo la maggioranza dei 27 acconsenta a imboccare una strada di questo tipo.
E se un aumento futuro rispetto ai 1.200 miliardi di euro è al momento difficile che si concretizzi, l’ipotesi che qualcuno debba invece rinunciare a qualcosa rispetto al passato si sta facendo strada in diversi settori interessati dal bilancio Ue. Uno per tutti, quello degli agricoltori. «Ho il trattore e sono pronto», ha avvertito Massimiliano Giansanti, capo della potente lobby agricola europea Copa, in risposta ai presunti tagli al massiccio bilancio dell’Ue per gli aiuti all’agricoltura. Non sono da meno gli aderenti a Coldiretti, che sono scesi in piazza a Bruxelles e a Roma per contestare i vertici comunitari con lo slogan «la tecnocrazia della von der Leyen costa più dei dazi Usa». «Siamo scesi in piazza perché è in gioco molto più del nostro futuro: è in gioco la democrazia e la stessa idea di Europa», dice da Bruxelles il presidente di Coldiretti Ettore Prandini puntando il dito contro «l’arroganza di una burocrazia europea che, sotto la guida della presidente von der Leyen, calpesta ogni giorno il lavoro degli agricoltori».
Altre sigle di categoria e lobby, a cominciare da quella del settore difesa, si stanno già muovendo su Bruxelles. Sia in senso figurato che non.