
Contro il fast fashion: con l’Epr sui rifiuti tessili, l’Italia dovrà cambiare passo
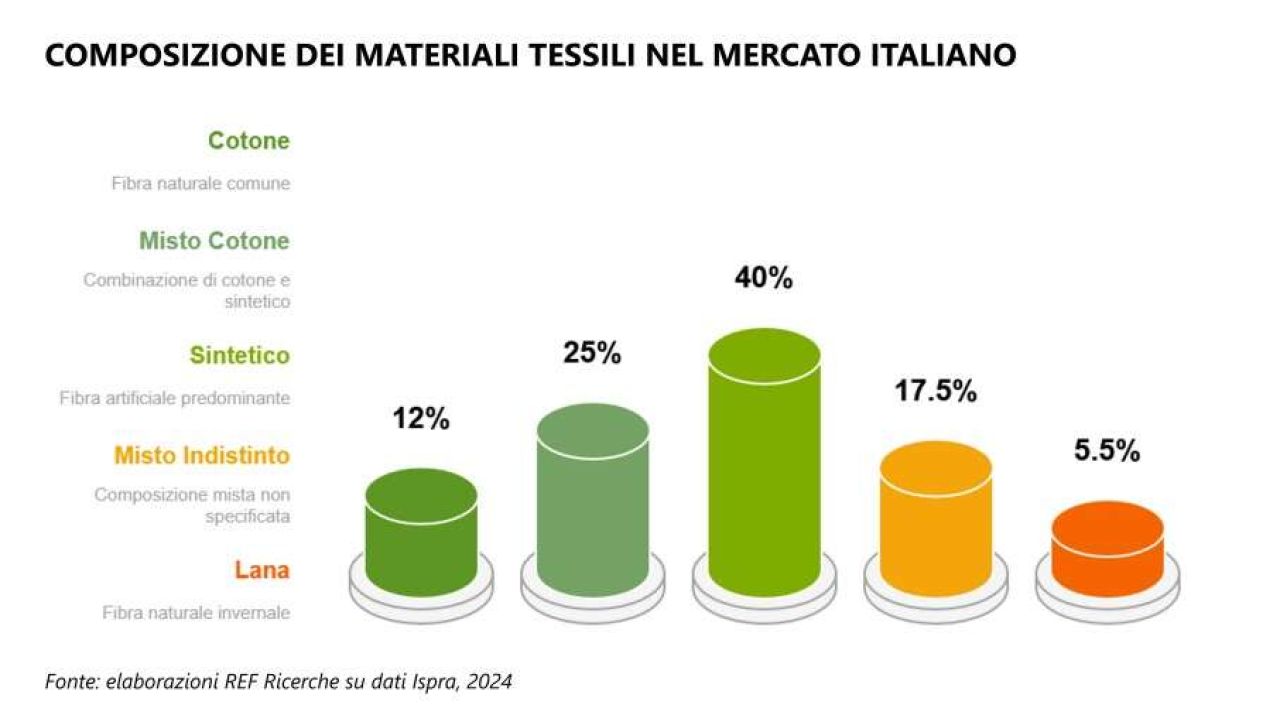
Il settore tessile è uno dei più impattanti dal punto di vista ambientale, soprattutto a causa della crescente diffusione della fast fashion, che accelera il consumo di capi a basso prezzo e di breve durata. L’Italia rimane uno dei principali produttori mondiali di tessuti, con oltre 13.000 aziende e un fatturato annuo di 1,6 miliardi di euro, concentrato prevalentemente nel segmento medio-alto. Allo stesso tempo, l’Italia è un grande consumatore di prodotti tessili, una buona parte prodotti all’estero (soprattutto quelli dilargo consumo), e nonostante l’introduzione del Decreto Legislativo 116/2020 che impone l’obbligo di raccolta differenziata, ancora oggi l’81% dei rifiuti tessili continua a finire in discarica o inceneritore. A fronte di questo, il governo italiano sta preparando l’introduzione di un sistema di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), che potrebbe trasformare la gestione dei rifiuti tessili, promuovendo il riuso, il riciclo e incentivando investimenti nella costruzione di impianti appositi, finora insufficienti.
Il quadro europeo e l’impatto del settore tessile
Nel 2020, l’Unione Europea ha generato circa 6,95 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, pari a 16 kg pro capite, ma solo una parte di essi (4,4 kg per persona) è stata separata per il riuso o il riciclo. La maggior parte dei rifiuti è stata incenerita o smaltita in discarica, con un impatto negativo sull’ambiente. Circa l’82% dei rifiuti proveniva dai consumatori, mentre il resto era costituito da rifiuti di produzione e capi mai venduti, un fattore che evidenzia inefficienze nella filiera.
Secondo la Commissione Europea, solo 1,41 milioni di tonnellate sono state trattate localmente, mentre una parte significativa è stata esportata, spesso con esiti problematici per l’ambiente e la società. Il riciclaggio delle fibre tessili è ancora limitato, e il materiale riciclato finisce prevalentemente in prodotti di bassa qualità (downcycling) destinati alla discarica dopo un breve ciclo di vita. La maggior parte dei capi non è progettata per durare e la combinazione di fibre naturali e sintetiche rende difficile ed economico il riciclo. Il fast fashion, in particolare, crea enormi volumi di prodotti che non possono essere facilmente trattati con i sistemi di riciclo attuali. Inoltre, l’esportazione dei rifiuti tessili verso paesi in via di sviluppo ha aggravato il problema, con materiali dispersi in ambiente, oppure destinati a discariche non regolamentate o a pratiche informali di downcycling, non valorizzando adeguatamente le risorse.
Il settore tessile ha un impatto ambientale rilevante, rappresentando il quarto maggiore settore per danni ambientali in Europa. In risposta, la Commissione Europea ha presentato la “Strategia UE sul tessile” nel marzo 2022, come parte del Green Deal europeo: essa mira a rendere il settore più sostenibile, attraverso misure che riguardano la progettazione dei prodotti, con l’introduzione di fibre riciclate e un sistema di informazioni più chiaro. Saranno introdotti requisiti più rigidi per combattere il greenwashing e un passaporto digitale per la tracciabilità dei prodotti; inoltre, sono previsti interventi per ridurre il rilascio di microplastiche dai tessuti. Un altro elemento della strategia è l’EPR, accompagnata da incentivi economici e misure di sostegno all’innovazione. Sempre secondo la Commissione, l’applicazione di principi circolari potrebbe aumentare il PIL europeo dello 0,5% entro il 2030, creando 700.000 nuovi posti di lavoro.
Con oltre 1,5 milioni di persone occupate in 160.000 imprese e un fatturato che ha raggiunto i 162 miliardi di euro nel 2019, la transizione ecologica del settore tessile europeo richiede una gestione attenta per evitare impatti economici e sociali negativi. La sfida è orientare le aziende verso modelli più responsabili, rispondendo alle crescenti richieste di sostenibilità e qualità.
Un settore in crisi profonda
Il settore dei rifiuti tessili sta vivendo una crisi profonda, alimentata proprio dall’aumento della fast fashion e dell’ultra fast fashion. Questi modelli di consumo hanno inondato il mercato di capi a bassa qualità, destinati a una vita breve, ma difficili da riciclare o riutilizzare, intasando così i centri di raccolta. In Europa, i sistemi di raccolta e valorizzazione dei rifiuti tessili sono costantemente sotto pressione, con un aumento dei rifiuti invenduti e difficili da gestire, che mette a rischio l’intero sistema di smaltimento. In Italia, per esempio, la raccolta differenziata del tessile è iniziata nel 2022, ma già emergono difficoltà nei distretti come Napoli, Ercolano e Prato. In Francia, il settore del riuso e del riciclo sta vivendo una paralisi, con la chiusura di punti di raccolta e la difficoltà di gestire i flussi di rifiuti. La Federazione belga dell’economia circolare ha lanciato un allarme, sottolineando come i costi di selezione e lavorazione superino i ricavi derivanti dalla vendita dell’usato.
La pandemia, la guerra in Ucraina e le difficoltà logistiche hanno accentuato la crisi, con la sospensione delle esportazioni di tessili usati verso i paesi africani, destinati storicamente ad accogliere abbigliamento di seconda mano. Ciò ha provocato una sovrabbondanza di rifiuti, con il rischio che finiscano in discarica o vengano inceneriti, aumentando l’impatto ambientale. L’esigenza, quindi, di avviare una governance sostenibile ed efficiente del post consumo tessile è una emergenza su scala internazionale
L’Unione Europea sta cercando di rispondere con politiche per incentivare il riciclo, ma sono necessari cambiamenti strutturali. Le proposte includono la riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti di riparazione, introdurre percentuali obbligatorie di contenuto riciclato e promuovere l’ecodesign. Un sistema di responsabilità del produttore, che obblighi le aziende a gestire i rifiuti tessili a fine vita, è cruciale per rendere il settore più sostenibile, ripartendo le responsabilità in modo equo tra gli attori della filiera, e ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti di bassa qualità.
L’evoluzione del settore in Italia
L’industria tessile italiana è un pilastro fondamentale del settore manifatturiero, con una posizione di rilievo a livello mondiale. Nel 2019, l’Italia si è classificata al terzo posto tra i principali esportatori di prodotti tessili, con un peso del 2,1% sulle esportazioni totali. Nonostante una lieve flessione (-3,4%) rispetto all’anno precedente, l’export tessile rimane un’importante voce nell’economia italiana, con destinazioni principali in Europa (69%), Asia (16,7%) e America (7,2%).
Il settore è dominato da piccole e microimprese, spesso artigianali, che, pur garantendo alta qualità e innovazione, devono affrontare la concorrenza di prodotti a basso costo provenienti da paesi extra-europei.
Nel 2023, il settore tessile italiano ha registrato un fatturato di circa 15,4 miliardi di euro, con 13.000 imprese e circa 112.000 addetti. Tuttavia, la crisi economica ha portato a un aumento delle chiusure di imprese rispetto alle nuove aperture. Il settore della moda, che include anche abbigliamento e pelletteria, ha registrato una contrazione del fatturato, previsto a circa 96 miliardi di euro nel 2024, con un calo del 6,5% rispetto all’anno precedente. Nonostante le difficoltà economiche, il settore continua a essere strategico per l’occupazione in Italia, con circa 451.000 addetti complessivamente nell’intero settore moda. I distretti tessili italiani, concentrati principalmente in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, nonostante le difficoltà degli ultimi anni continuano a essere un punto di riferimento per qualità e innovazione, con Biella, Como e Prato che sono famosi per i loro tessuti di lana, seta e filati.
Tuttavia, la crescente globalizzazione ha ridotto l’autosufficienza della produzione italiana, con un aumento della dipendenza dall’estero per le materie prime naturali. Ciò ha reso il settore vulnerabile alle fluttuazioni dei mercati internazionali e ai costi logistici in aumento. Inoltre, la gestione dei rifiuti tessili è diventata una questione sempre più critica. Ogni anno, l’industria della moda produce circa un milione di tonnellate di rifiuti, una parte dei quali finisce in discarica o viene incenerita.
Nel 2023, in Italia solo una piccola parte dei rifiuti tessili prodotti è stata avviata alla raccolta differenziata (circa 172.000 tonnellate), una cifra ancora marginale rispetto alla produzione totale. Si stima che circa il 6% dei rifiuti indifferenziati sia composto da tessili, una percentuale che potrebbe arrivare al 25% considerando anche i rifiuti industriali e i trattamenti meccanici. La raccolta differenziata dei rifiuti tessili è ancora in fase di sviluppo, con notevoli differenze tra le regioni: al Nord si raccolgono più di 2,8 kg di tessili per abitante all’anno, mentre al Sud si arriva a circa 2 kg.
La gestione dei rifiuti tessili in Italia, tra sfide e opportunità
A partire dal 1° gennaio 2022, l’Italia ha dovuto adeguarsi alle normative europee per la gestione dei rifiuti tessili, introducendo l’obbligo di raccolta differenziata di questi materiali. Questo obbligo, previsto dal Decreto Legislativo 116/2020, recepisce quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2018/851. Sebbene la legge imponga alle amministrazioni comunali di organizzare una raccolta separata dei rifiuti tessili, sul campo emergono numerose difficoltà, soprattutto legate alla mancanza di indicazioni operative precise e, soprattutto, all’assenza di una filiera strutturata sulla valorizzazione di tutte le frazioni, non di quanto sarà destinato al riuso. La legge lascia infatti spazio di manovra agli enti locali e agli operatori privati, creando una situazione complessa.
In Italia, la gestione della raccolta differenziata tessile si caratterizza per una grande frammentazione: il settore della raccolta è prevalentemente gestito da cooperative sociali e organizzazioni no-profit, che operano soprattutto nel nord del paese. Le raccolte originali (non selezionati) vengono vendute ai selezionatori con finalità orientate verso il riuso, l’unica frazione che finora è stata in grado di trainare economicamente il settore. Le raccolte originali possono essere acquistate dai selezionatori italiani anche dall’estero (soprattutto Nord Europa), così come può accadere anche il contrario (soprattutto verso la Tunisia). Pe esempio, nel 2019 sono state esportate dal nostro paese circa 68.200 tonnellate tra rifiuti tessili, quali indumenti ed accessori usati, scarti di selezione e rifiuti da fibre tessili lavorate. Di queste, circa 48.300 tonnellate (ovvero la maggior quota) erano rappresentate da rifiuti quali indumenti ed accessori usati. La maggior quantità delle raccolte originali, oltre ai paesi dell’Est UE (Romania, Ungheria e Bulgaria), risulta comunque essere stata acquistata dalle imprese della selezione presenti in Tunisia, per un quantitativo formalizzato che ha superato le 38 mila tonnellate. Insomma, si tratta di un mercato profondamente interconnesso con il resto del mondo.
Uno degli ostacoli principali riguarda la qualità della raccolta. I rifiuti tessili non vengono sempre separati correttamente, e spesso contengono contaminanti come plastica e metalli, riducendo il potenziale riciclabile. Si stima che solo circa il 50% dei rifiuti tessili raccolti venga effettivamente riutilizzato o riciclato, mentre il resto finisce in discarica o viene esportato verso paesi dove il trattamento avviene a basso valore. Ciò rende la gestione dei rifiuti tessili una delle maggiori sfide per l’economia circolare in Italia, ma allo stesso tempo, offre un’opportunità per migliorare la sostenibilità ambientale del paese.
Un passo importante verso una gestione più sostenibile è rappresentato dall’imminente introduzione di uno schema di EPR, come stabilito dal Decreto Legislativo 116/2020. Questo strumento obbliga i produttori di abbigliamento, scarpe e altri prodotti tessili a farsi carico della gestione del fine vita dei loro prodotti. I produttori devono organizzare, finanziare e gestire la raccolta, il riciclo e il riutilizzo dei loro prodotti al termine del loro ciclo di vita. Sebbene l’EPR abbia avuto successo in altri settori, la sua futura applicazione nel pone interrogativi e preoccupazioni legittime da parte di tutti gli attori coinvolti.
La principale difficoltà nell’attuazione dell’EPR è capire quale sarà la geometria della nuova governance, ovvero come saranno distribuiti ruoli e responsabilità, tenendo conto della doppia esigenza di garantire una vera transizione ecologica del settore e, allo stesso tempo, sostenere una efficienza economica, evitando che questa si possa generarsi solo a scapito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, quindi scaricandosi sulla bolletta pagata dai cittadini (che già dovranno sostenere la spesa del contributo ambientale, che i produttori/distributori è lecito attendersi scaricheranno sul prezzo finale di ogni prodotto tessile). Serve quindi rafforzare, oltre alla raccolta (che deve diventare capillare e comprensiva anche dei rifiuti tessili, quindi non solo abbigliamento usato) l’eco-progettazione, disincentivando l’immissione nel mercato di manufatti non riusabili né riciclabili, così come urge costruire una scala industriale praticabile per il riciclo di tutto ciò che non può andare a riuso, per un uso efficiente delle risorse e per evitare ulteriori impatti ambientali. Senza dimenticare che il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti tessili non è esente da pratiche illecite, con alcuni operatori che raccolgono e/o smaltiscono i rifiuti in modo illegale, spesso con proiezioni internazionali (dumping ambientale), con impatti negativi sull’ambiente e sulla competitività delle aziende che rispettano le normative.
Un altro problema rilevante è la scarsa sensibilizzazione e informazione dei consumatori. Nonostante gli sforzi delle amministrazioni locali e delle ONG, molti cittadini non sono ancora completamente consapevoli dell’importanza di una corretta gestione dei rifiuti tessili. Le campagne di sensibilizzazione sono fondamentali per educare la popolazione e incoraggiare comportamenti responsabili. Inoltre, la mancanza di punti di raccolta facilmente accessibili e pubblicizzati limita la partecipazione attiva dei cittadini alla raccolta differenziata.
Conclusione
Se finora il settore si è mosso quasi esclusivamente sulla preparazione per il riutilizzo, la frazione col più alto valore aggiunto, concedendo poco spazio alle politiche di prevenzione, trascurando anche il recupero di materia, sono esattamente questi gli anelli mancanti che dovrebbero essere introdotti dalle nuove politiche.
Condivisibilmente, la nuova governance che si vuole costruire a livello europeo, e che il nostro paese sta provando a declinare, intende puntare su una filiera in grado di coprire sia la produzione che il pre-consumo con il post-consumo. Integrazione vista come uno snodo cruciale verso la transizione ecologica dell’intero settore, sebbene con le debite differenze, in particolare considerando che il pre-consumo ruota attorno alla gestione di mercato dei rifiuti speciali mentre il post-consumo gravita all’interno della gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
In tal senso, l’imminente schema di EPR che verrà licenziato dal MASE, ultimate le fasi di confronto con gli stakeholder, dovrebbe servire a costruire una filiera integrata di tipo industriale in cui, insieme alle pratiche di riduzione, tutte le frazioni possano andare, prima di tutto, a riutilizzo e il resto a riciclo e, in subordine, a recupero di energia.
L’avvio di una filiera integrata, a monte retta da una raccolta finalmente capillare e orientata a tutte le frazioni tessili (quindi, ripetiamolo ancora, non solo abbigliamento), e a valle dal sostegno di misure economiche di incentivo all’uso di tessuti e fibre riciclate, dovrebbe servire anche a creare le condizioni per attivare gli investimenti per la costruzione degli impianti destinati al riciclo. Segmento, quest’ultimo, rimasto ancora sullo sfondo, principalmente per operare in mercati che mostrano evidenti segni di fallimento.











