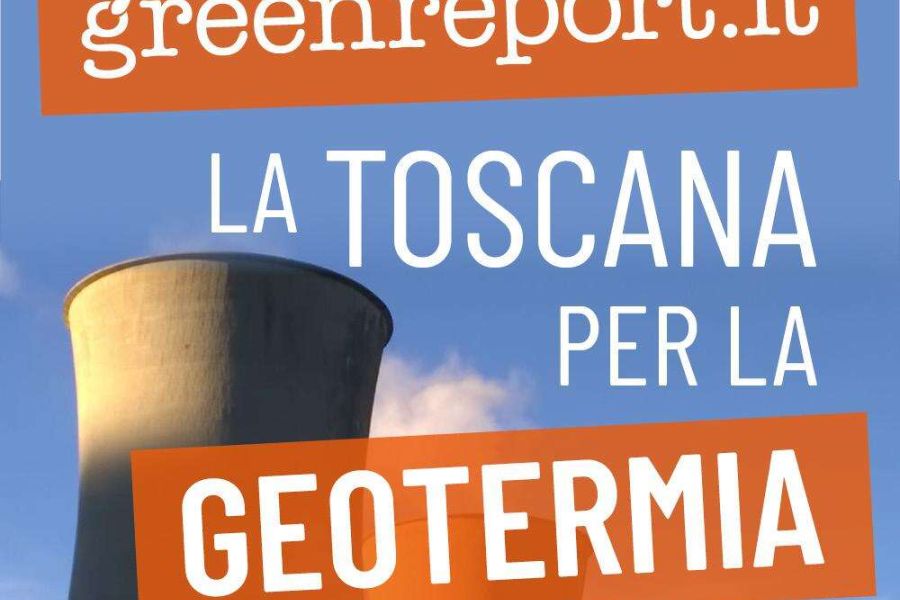Il nucleare in Europa crescerà da 98 a 109 GW al 2050. Il costo? 241 miliardi di euro

Mentre Israele sta bombardando i siti d’arricchimento dell’uranio in Iran, confermando le tecnologie nucleari tra i principali obiettivi militari in caso di guerra, la Commissione europea pubblica l’ottavo aggiornamento del proprio Programma indicativo nucleare (Pnic), in cui vengono valutate le esigenze d’investimento nel settore in base ai piani presentati dagli Stati membri in materia.
Tutte le tecnologie sono chiamate in causa: oltre alle centrali tradizionali si spazia a quelle ad oggi inesistenti sotto il profilo commerciale, dai piccoli reattori modulari (Smr) ai reattori modulari avanzati (Amr) ai microreattori, fino alla fusione nucleare guardando «a lungo termine». Materia d'interesse anche per l'Italia, dunque, che almeno a parole ha ripreso l'avventura nucleare sotto il Governo Meloni.
«Per alcuni paesi dell'Ue – dichiara la Commissione – l'energia nucleare è una componente importante delle strategie di decarbonizzazione, competitività industriale e sicurezza dell'approvvigionamento. La Commissione stima che oltre il 90% dell'elettricità nell'Ue nel 2040 sarà prodotta da fonti decarbonizzate, principalmente rinnovabili, integrate dall'energia nucleare. Si prevede che la capacità nucleare installata in tutta l'Ue aumenterà da 98 GWe nel 2025 a circa 109 GWe entro il 2050 […] La realizzazione dei piani degli Stati membri in materia di energia nucleare richiederà investimenti significativi, pari a circa 241 miliardi di euro entro il 2050, sia per l'estensione della durata di vita dei reattori esistenti che per la costruzione di nuovi reattori su larga scala».
Più nel dettaglio, la Commissione stima uno scenario di 109 GWe di capacità nucleare installata entro metà secolo (con un intervallo di incertezza compreso tra 70 GWe e 144 GWe). Questo scenario richiederebbe comunque investimenti per circa 241 miliardi di euro al valore attuale: «205 miliardi di euro per lo sviluppo di nuovi reattori su larga scala e 36 miliardi di euro per il prolungamento della vita utile di quelli esistenti».
«La realizzazione di questi investimenti – argomentano da Bruxelles – richiederà una combinazione di diverse fonti di finanziamento pubbliche e private, integrate da strumenti di de-risking. Gli strumenti previsti dalla riforma del mercato elettrico, in particolare i "contratti per differenza a due vie" (Cfd), consentono agli Stati membri di supportare gli sviluppatori di progetti attraverso la riallocazione dei rischi legati al mercato elettrico e alla costruzione. Inoltre, il finanziamento di un progetto può basarsi su contratti di acquisto di energia (Power purchase agreement, Ppa), che gli Stati membri possono concepire come strumenti di supporto rivolti al produttore».
Per il nucleare in Europa si prospetta dunque un quadro sostanzialmente stabile nei prossimi venticinque anni, prendendo a riferimento lo scenario medio della Commissione, che prevede un incremento di capacità installata rispetto all’attuale di appena 11 GW. Per avere una pietra di paragone, basti osservare che solo dal 2022 al 2024 sono stati installati in Ue circa 205 GW di capacità elettrica rinnovabile (una cifra superiore all'aumento registrato tra il 2014 e il 2022); sempre la Commissione Ue stima che «i consumatori di elettricità dell'Ue abbiano risparmiato circa 100 miliardi di euro nel periodo 2021-2023 grazie alla produzione di elettricità aggiuntiva da impianti fotovoltaici ed eolici di nuova installazione». Non va molto meglio ampliando il quadro d'osservazione al perimetro globale: in base all'ultimo rapporto Iea in materia, a livello internazionale gli investimenti in corso sulle fonti rinnovabili sono dieci volte superiori a quelli sul nucleare.