
L'atomo fuggente. Per Bankitalia il nucleare in Italia non abbasserebbe il costo delle bollette
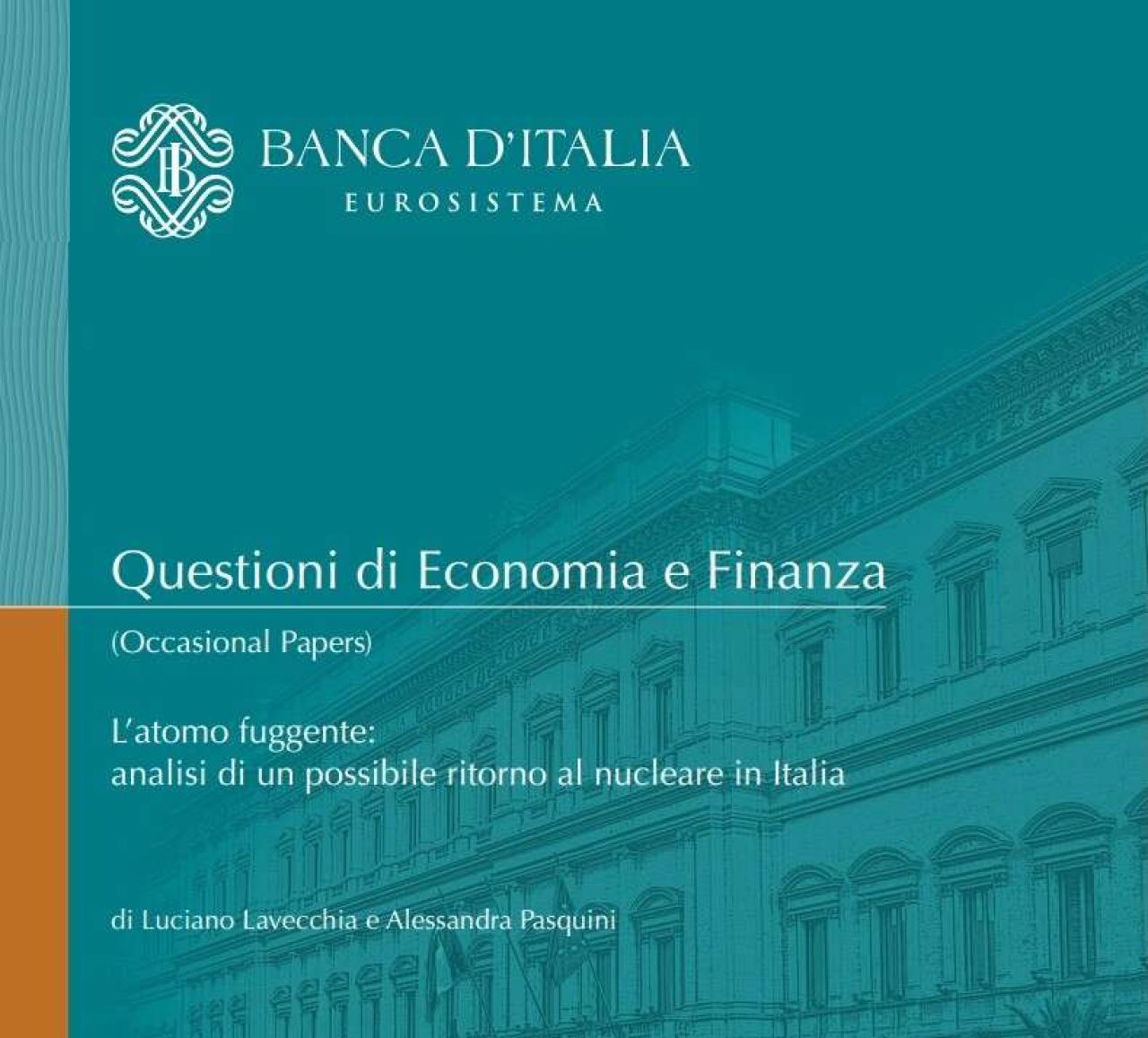
La Banca d’Italia ha appena pubblicato un’analisi in merito al possibile ritorno dell’energia nucleare in Italia, previsto dal Governo Meloni nel Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) e confermato dagli scenari della Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile (Pnns) creata dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, nonostante la cornice legislativa per il rilancio dell’energia atomica nel Paese dovrebbe essere pronta non prima di fine 2027 – ovvero dopo le prossime elezioni legislative.
Già dal sommario dell’analisi, Bankitalia evidenzia che «dati la struttura del mercato e della bolletta elettrica, una reintroduzione del nucleare non avrebbe significativi impatti sul livello dei prezzi. Piuttosto, potrebbe ridurne la volatilità, contribuendo a stabilizzare la spesa per l’elettricità per i sottoscrittori di contratti a lungo termine», un vantaggio che è però possibile conseguire anche utilizzando contratti a lungo termine (come Cfd e Ppa) disponibili per le fonti rinnovabili.
«Sul fronte della dipendenza energetica – continua Bankitalia – la riduzione delle importazioni di idrocarburi sarebbe compensata da una maggiore importazione della tecnologia e del combustibile per la produzione nucleare, in questo momento concentrati in paesi geo-politicamente poco affini all’Italia. Il contributo di una reintroduzione del nucleare alla riduzione delle emissioni di gas serra è invece potenzialmente consistente», ma in questo caso vanno fatti i conti con le tempistiche di realizzazione: una nuova centrale per diventare operativa impiega da 10 a 19 anni a livello globale, coi siti Ue verso il limite superiore, il che significherebbe continuare a mantenere alti i livelli di emissione legati all’impiego delle fonti fossili fino alle soglie del 2050, ovvero il limite massimo entro quando dovrà essere raggiunta la neutralità carbonica.
«Un altro elemento importante che emerge dall’analisi – snocciola ancora Bankitalia – sono le incertezze legate alle tecnologie scelte, gran parte delle quali non sono ancora disponibili per la commercializzazione. Tali incertezze rendono opportuno un approccio cauto, che predisponga e promuova anche strategie alternative».
Non a caso gran parte dei reattori attivi in Europa oggi è «il risultato di ingenti investimenti avvenuti in risposta agli shock petroliferi negli anni settanta e ottanta», quando le rinnovabili ancora non erano competitive e molte delle relative tecnologie non esistevano neanche, mentre oggi i nuovi operatori privati «privilegiano tecnologie a minore intensità di capitale e con tempi di costruzione molto più rapidi», come le rinnovabili.
In Europa vi sono tre impianti in costruzione, e altri due in progettazione, che «hanno subito numerosi ritardi e aumenti dei costi». È questo il quadro in cui il Governo suggerisce l’impiego delle nuove tecnologie modulari di piccole dimensioni ad ora ancora in progettazione (in particolare gli Smr a partire dal 2030, gli Amr di quarta generazione verso il 2040): «Nello scenario ipotizzato dal Pniec – riassume Bankitalia – la capacità installata tra il 2030 e il 2050 sarebbe pari a circa 8 GW (di cui 1,3 GW in modalità cogenerativa e 0,4 GW da fusione nucleare nel 2050). I nuovi impianti sarebbero tra 22 e 42, e la loro produzione coprirebbe l’11% (64,2 TWh) del fabbisogno elettrico stimato al 2050».
Dove sarebbero localizzate dalle 22 alle 42 centrali nucleari ovviamente non è dato sapere – il Governo sembra aver rinunciato anche a realizzare il pur necessario Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, vista la netta contrarietà dei territori anche governati dal centrodestra – gli effettivi costi delle nuove tecnologie nucleari «tuttavia presentano un’elevata incertezza perché nella gran parte dei casi non sono ancora stati costruiti i first-of-a-kind», ricorda Bankitalia.
Considerando una misura di costo sviluppata dall’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) che incorpora il contributo della tecnologia all’efficienza del sistema energetico (Valcoe), al 2040 in Europa «i nuovi impianti nucleari di piccole dimensioni sarebbero competitivi con il fotovoltaico utility-scale con sistemi di stoccaggio solo a fronte di un costo del capitale particolarmente basso», ovvero assumendo che «il costo medio ponderato del capitale sia pari al 4% (una prospettiva ottimistica considerato che la Iea lo assume generalmente pari all’8-9% per le tecnologie nucleari)».
C’è poi il tema della dipendenza tecnologica, dato che «le tecnologie dominanti negli ultimi 25 anni sono state quelle cinesi, sviluppate prevalentemente per il mercato domestico, e russe», mentre «sebbene la Pnns esprima un giudizio positivo sul know-how tecnologico degli operatori italiani, la loro esperienza è limitata, soprattutto nell’ambito della costruzione degli impianti». A quest’aspetto si lega quello delle materie prime, considerato che «la produzione di uranio naturale è molto concentrata e vi contribuiscono 17 paesi, 6 dei quali (Kazakistan, Canada, Namibia, Australia, Uzbekistan e Russia) nel 2022 coprivano da soli il 90% del totale»; particolare non trascurabile, il 43% dell’uranio viene estratto in Kazakistan, un Paese molto vicino alla Russia di Putin.
In sintesi, per Bankitalia «vi sono alcuni aspetti problematici della reintroduzione del nucleare in Italia, legati all’impatto sull’ambiente, al finanziamento del nucleare e alla potenziale opposizione da parte dell’opinione pubblica», spaziando dalla gestione delle scorie e uso dell’acqua fino alle modalità di finanziamento.
«Si conferma che l’elettronucleare, in sostituzione delle fonti fossili, potrebbe svolgere un ruolo nel ridurre la volatilità del prezzo dell’elettricità (in particolare grazie alla possibilità di utilizzare forme di contratti a lungo termine), ma difficilmente – conclude Bankitalia – avrebbe un impatto significativo nel contenimento del livello dei prezzi finali. Ciò è dovuto principalmente al modello di funzionamento del mercato elettrico, dalla struttura delle componenti tariffarie e degli oneri che contribuiscono a definire il prezzo finale dell’elettricità pagato dagli utenti.
Di fronte a queste incertezze, è necessario adottare un approccio prudente nel considerare il ruolo che la reintroduzione del nucleare potrebbe avere nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Governo, valutando e preparando anche strategie alternative. In questo senso l’ampliamento del dibattito sulle opzioni disponibili, stimolato dalle recenti iniziative governative – e aperto anche a tecnologie ancora in fase di sviluppo – offre potenziali vantaggi a condizione che non ostacoli né rallenti il progresso di altre strategie per la diversificazione del mix energetico, in particolare l'espansione delle fonti rinnovabili. Va riconosciuto infine che, quale che sia la soluzione tecnica, difficilmente la creazione di nuovi impianti nucleari potrà esimersi da una compartecipazione del pubblico, o come investitore diretto, con finanziamenti o sussidi, oppure indirettamente, mediante società partecipate».
Vale la pena sottolineare, se questo è il contesto, che a livello globale il volume d’investimenti sul nucleare è oggi minore di 10 volte rispetto a quello indirizzato sulle rinnovabili, e che l’espansione delle fonti rinnovabili nel nostro Paese è già oggi rallentata contesto normativo e autorizzatorio sempre più caotico.
Entro il 2030 l’Italia dovrà raggiungere, secondo quanto previsto dal decreto Aree idonee, 80.001 MW di nuova potenza considerando le installazioni realizzate a partire dal 2021. Un obiettivo lontano, dato che con le installazioni degli ultimi quattro anni il Paese ha raggiunto appena il 24,1% dell’obiettivo (19.297 MW di nuova potenza installata dal 2021 al 2024). Per colmare questo ritardo, snocciola Legambiente, l’Italia dovrà realizzare nei prossimi 5,5 anni 60.704 MW, pari ad una media di 11.037 MW l’anno: parliamo di almeno 3.557 MW in più rispetto a quanto fatto nel 2024 (7.480 MW).












